Gli eroi in bianconero: Mario VARGLIEN

La maglia della mia vita ha avuto due soli colori – raccontava – il bianco e il nero ed era a strisce. Adesso tutti quelli che non mi conoscono penseranno che io sono nato alla Juventus e alla Juventus sono morto, come calciatore, si intende. Allora mi accorgo che devo precisare. Non sono cresciuto alla Juventus, io sono di Fiume. I primi calci, lo sapete, si tirano senza importanza, sin da bambini. Se uno, però, è destinato a fare il calciatore di professione, ecco che prima o poi arrivano i suoi primi, calci ufficiali. Per me questi sono arrivati che avevo sedici o diciassette anni, non lo ricordo con assoluta esattezza, in ogni caso ero un pivello e giocavo per l’Olimpia e Gloria di Fiume e la mia maglia era appunto bianconera, come quella della Juventus. Così ora mi sono in parte già spiegato.
A un certo momento, Olimpia e Gloria si fusero nella Fiumana: eravamo in Serie B. Io gironzolavo di ruolo in ruolo. Ora all’attacco come mezzala, ora in difesa come mediano o centromediano. Ero, come tutti i giovani, in cerca di una posizione stabile, nella vita e nel calcio, che per me era la vita, anche se debbo confessare che ero abbastanza versatile come sportivo praticante: nuotavo discretamente, giocavo a basket, facevo ginnastica.
Qualcuno mi diceva che io ero un generico dello sport e che perciò ero destinato a non eccellere in un campo specifico. Io sapevo che il calcio l’avevo nel sangue e, siccome ritengo di essere sempre stato un duro, ancor più verso me stesso che verso gli altri, ho puntato i piedi ed ho vinto la mia battaglia, anche se non è stato facile.
Avevo superato da poco i diciassette anni, quando giocai (in maglia azzurra) con la rappresentativa della Venezia Giulia contro quella del Veneto, a Udine. Mi misi in luce, tanto è vera che la Pro Patria, che era stata promossa in Serie A, mi acquistò. Ed io, ancora giovanissimo, esordii in Serie A, udite udite, con la Pro Patria a Bologna. Il Bologna era Campione d’Italia! Quel giorno, memorabile anche per i bolognesi, io ero centromediano. Si perdeva, logicamente, si perdeva per 1-0 e fui proprio io che, a sei minuti dalla fine, segnai il goal del pareggio per la Pro. Avevo vent’anni, l’età dei sogni di gloria!
A casa mia mi dicevano: gioca pure al football, ma devi anche lavorare. Ed io lavoravo in banca, a Busto. Lavoravo, mi allenavo e la domenica giocavo. Poi, nel 1927-28, venne lo scossone decisivo della mia vita: venne a cercarmi la Juventus. Io ero ai sette cieli, mi sembra che fosse umano, ma la Pro Patria non voleva saperne di mollarmi. Mi chiamarono i dirigenti e mi dissero: «Varglien, resti, le daremo quel che le offre la Juventus».
I quattrini non hanno colore, le maglie sì, quella della pur amatissima Pro Patria non valeva quella della Juventus. Mi toccavano tutti sul sentimento, dicevano che sarei dovuto rimanere a Busto, lì mi volevano bene. Ero indeciso e, mentre ero indeciso, mi infortunai. La Juventus, intanto, stava aspettando, Quando arrivammo al dunque, seppi che la Pro Patria non era più disposta a mantenere le sue promesse finanziarie. Feci una sola cosa: le valige e me ne tornai a Fiume, ero un tipo abbastanza deciso. Ma, ricordo, il 31 agosto, mi arrivò un telegramma: finalmente era stato ceduto alla Juventus! La Juventus, ora, mi dava meno quattrini, ma a me la cosa non interessava: il passo era fatto e basta, la mia vita aveva avuto la svolta che tanto avevo desiderato. Avevo, in quei giorni, ventidue anni.
Venni a Torino, alla Juventus, e alla Juventus restai quattordici anni, dico quattordici; correva il 1928, l’anno in cui si fondarono le basi definitive della più grande Juventus di tutti i tempi. Io era titolare, mediano destro o sinistro. La Juventus aveva acquistato anche Orsi e Caligaris: i tre nuovi eravamo noi. Combi, Rosetta e Caligaris, Varglien I, Monti e Bertolini. Con Caligaris e Bertolini che giocavano a sinistra ed erano entrambi tutti destri, con Rosetta e Varglien che giocavano a destra e che preferivano calciare con il sinistro! Io, Orsi e Caligaris, i tre novellini, ci facevamo compagnia, avevamo fatto gruppo a sé, ma non tardammo a inserirci nella grande famiglia che, tutta unita, conquistò i cinque scudetti. Anni, quelli, che non scorderò mai, gli anni migliori della mia vita e della mia carriera. Fra l’altro, una volta giocai in Nazionale A, a Roma contro la Francia (e vincemmo 2-1) e undici o dodici volte giocai in Nazionale B.
Combi in porta, Rosetta non marca nessuno, io penso all’ala destra, Bertolini all’ala sinistra, Monti marca il centravanti. Se l’avversario che dobbiamo affrontare ha classe, allora la marcatura è seria, altrimenti si gioca come sappiamo noi, ignorando l’avversario. Quando dovevamo giocare contro Sindelar, il compito di marcarlo era mio, perché Monti non lo pigliava mai e si imbufaliva. Anche Braine e Meazza ci facevano soffrire. Le nostre bestie nere erano la Roma e la Lazio. Io davo del “lei” anche a Bigatto. Faotto, terzino del Palermo, voleva acciaccare Orsi. Orsi, muovendo il piedino fantastico che aveva, lo azzoppò. Quando si vinceva lo scudetto c’erano serate d’onore al Carignano. Orsi era il più pagato, prendeva 1.000 pesos, cioè 700 lire al mese più una villa e un’automobile. Quando il pesos andò giù, la Juventus gli corrispose sempre la stessa cifra.
Non so che significa classe. Io ho imparato dai campioni dello Spartak che venivano a giocare a Fiume, come Kada, Janda, Kelacef. Mi spaccavo gli occhi per capire come stavano in campo. Ho giocato tante volte centromediano nella conquista dei miei cinque scudetti.
Dopo ogni allenamento Rosetta andava ad asciugarsi e si curava le scarpe come cose sacre. Monti era sempre troppo serio e andava d’accordo solo con Bertolini. Combi nelle sue uscite dai pali ci terrorizzava. Una volta il suo pugno riuscì a beccare anche me. Rimasi svenuto cinque minuti. Rosetta si portava nella valigia in trasferta per scaramanzia il vestito nero, quello con il quale si era sposato. Era un grandissimo giocatore, però nella partita facile si sfaticava. Come terzino faceva in un tempo solo quello che gli altri facevano in due o tre tempi. Passava al volo di prima tutti i palloni. Non ne colpì mai uno di testa. Orsi era simpatico, suonava il violino, mi chiamava spesso al telefono e mi diceva: «Ascolta questo tanghito!» Cesarini era una testa pazza, ci faceva ammattire tutti.
A fine carriera, oramai nel 1941-42, giocai nella Sanremese, che era una dépendance della Juventus (campionato di guerra) e infine tornai a Trieste, dove disputai le mie ultime partite. Ricordo quella contro una squadra militare tedesca. Io ero il capitano, con me c’era anche Nereo Rocco. Invasione di campo, calci e pugni: non ci tiravamo indietro! Ho appeso le scarpe al chiodo a trentasei anni, nel 1942. Da allora sono diventato più juventino di prima.
ALBERTO FASANO, DA “HURRÀ JUVENTUS” DEL SETTEMBRE 1978
Rievocare su queste pagine l’indimenticabile figura di Mario Varglien potrebbe risultare arduo per chi abbia avuto una conoscenza superficiale dell’uomo e del giocatore. Io, che ragazzino militante nelle squadre minori della Juventus, ho avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo, trovo facile ripresentare ai lettori il personaggio che per quindici anni è stato un po’ il simbolo di fedeltà alla società bianconera. Anche oggi le statistiche ricordano che soltanto due giocatori, Giampiero Boniperti, la bandiera stessa della Juve, e Giovanni Varglien, fratello dello scomparso, hanno giocato un maggior numero di partite con la maglia bianconera. Già questo rilievo giustificherebbe l’importanza che l’amico Mario ebbe nella storia della società. Ma esistono anche fattori di carattere tecnico.
Prima dell’avvento di Luisito Monti, il fiumano Mario Varglien fu senz’altro uno dei due grandi centromediani della Juventus: l’altro era stato l’ungherese Viola. Quello del centromediano è uno dei più controversi e impegnativi ruoli affidati a un giocatore di calcio. Naturalmente il nostro discorso è valido se si tiene conto di come si giocava a calcio dalla fine della Prima Guerra Mondiale all’inizio della seconda. Abbiamo detto controverso, perché a quei tempi erano tutt’altro che esaurite o appianate le discussioni circa le sue attribuzioni, oscillanti tra i compiti di rottura e i compiti di lancio; abbiamo detto impegnativo perché si imperniavano in esso l’impostazione, la struttura e il movimento dell’intera squadra.
Per quanto, infatti, il mediocentro sistemista non abbia più avuto le consegne particolarissime del mediocentro “metodista” di una volta, è un fatto che dalla sua condotta dipendeva, a gioco virtualmente fermo, la registrazione generale della squadra. Mario Varglien ha giocato con il Metodo, ma sarebbe stato fortissimo anche con il Sistema: possedeva scatto, vigore, elasticità e intuito per svolgere un lavoro tanto oneroso e complesso. Chi ha avuto modo di vederlo giocare, non può aver dimenticato quella figura.
Mario era un combattente nato, che eseguiva il suo lavoro senza disperdersi in azioni confuse e avventurose, ma incanalava la sua condotta tra le sponde della sagacia, dell’ordine e del rendimento concreto. Giocava, come avrebbe poi detto molti anni dopo Bruno Roghi, «a pugni chiusi e a occhi aperti». Era di statura superiore alla media. Morfologicamente apparteneva alla categoria dei giocatori raccolti e compatti come mastini di battaglia, sempre sicuri del balzo utile per addentare la preda, nel nostro caso la palla di cuoio. Stava probabilmente nel suo istintivo e felice tempismo, nel balzo il segreto della sua abilità nello svolgere il gioco di testa: è il tempismo che gli consentiva di anticipare avversari più alti, ma più tardi di lui.
Con la duttilità che solo i giocatori di classe posseggono, Mario Varglien seppe poi trasformarsi da centromediano in mediano laterale e, dotato com’era di scatto e velocità, anche in ala o addirittura centrattacco. È stato quello che si dice un jolly di gran lusso. È chiaro, tuttavia, che il suo ruolo preferito fu quello di laterale, in coppia con Bertolini e avendo a fianco un colosso come Luisito Monti.
Mario aveva nell’istinto la scelta di tempo necessaria per entrare nel midollo dell’attacco in marcia e sapeva realizzare il suggerimento con la prontezza, la sicurezza e soprattutto la chiarezza d’accento che distinguevano i veri mediani “sistemisti”. Il loro paragone con lo stantuffo della locomotiva è pertinente al moto e alla funzione del loro gioco, ora di spinta alla ruota, ora di trazione per assicurare la continuità d’impulso. Gli giovava molto l’attrezzatura atletica per la quale madre natura non aveva adoperato con avarizia la sua creta; la natura aveva messo in piedi un Varglien robusto, solido, resistente. Sono doti non comuni che, coordinate dall’addestramento e riscaldate dal temperamento, plasmano il classico giocatore di battaglia, a buon rendimento quando la partita è piana, a rendimento eccezionale quando la partita è scabrosa.
Ciò che massimamente si notava nel suo impianto e nella sua condotta di gioco era la positività del rendimento, sempre ad alto livello per intere stagioni. La sua tecnica (forse, ma non ne siamo certi) non brillava per invenzioni virtuosistiche: Mario stava alla sostanza e non alle apparenze del gioco; perciò cercava sempre di giocare più per la squadra che per se stesso, più per il risultato che per la platea. In questo senso la sua tecnica era stringata e asciutta: un periodo ordinato e organico, senza aggettivi svolazzanti che spesso avvolgono il poco arrosto nel molto fumo del discorso sportivo.
È stato un giocatore duro, ma un atleta leale; mai lo abbiamo visto colpire a tradimento un avversario, ma se qualcuno cercava di provocarlo, non poteva certo prevedere i confini della reazione di Varglien. Indimenticabili i suoi duelli con Silano, l’ala sinistra di un Torino battagliero e deciso. Mario opponeva tecnica a tecnica, sia pure premendo il pedale delle risorse atletiche che in lui parevano inesauribili.
Da quanto abbiamo sinora scritto di lui e per lui, pensiamo balzi fuori la figura di un giocatore completo e maturo, di un uomo che sapeva conservare anche nei frangenti più burrascosi, la chiarezza di visione e la freddezza di esecuzione che i giocatori di media tacca sono soliti perdere lasciandosi avviluppare dai tentagli velenosi dell’orgasmo.
Giocò quindici anni con la maglia della Juventus, conquistò cinque scudetti consecutivi, vinse tre volte il titolo mondiale con la Nazionale goliardica selezionata dal dirigente juventino Benè Gola; disputò numerose partite con la Nazionale B ed ebbe la soddisfazione di indossare anche la maglia azzurra dei moschettieri a Roma contro la Francia. Un grosso personaggio del calcio bianconero e del calcio nazionale.
Ora Mario ci ha lasciati per sempre. È andato a raggiungere morti suoi cari amici, compagni di tante battaglie: Combi, Rosetta, Caligaris, Varglien, Bertolini, Sernagiotto, Cesarini, Vecchina. Lassù c’è mezza Juve degli anni d’oro.
RENATO TAVELLA
E pensare che il tutto non era nato sotto i migliori auspici. Anzi. Al primo approccio con la beneamata, dopo le due timide parole di convenzione e quattro sani calci, il nostro in premio era finito all’ospedale col naso fracassato. Niente di voluto, ben inteso: un casuale scontro di gioco con uno dei due fratelli Brotto, per la precisione, quello che giocava all’attacco. Insieme si erano lanciati per aria con genuina foga, ben intenzionati a colpire entrambi il pallone che spioveva dal cielo. Ne era venuta fuori una gran capocciata. Risultato: Mario Varglien era rimasto stordito a terra, la faccia insanguinata. Subito a soccorrerlo si era precipitato il professor Ferrero, medico sociale bianconero, mentre Brotto, avvertita la gravità dello scontro, non sapeva più come giustificare l’accaduto con gli altri compagni.
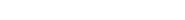





 Siamo al termine del 2024. Un anno, sportivamente parlando, piuttosto intenso per chi vive con DNA bianconero. È successo di tutto. Non c’è più Allegri ma ora, sulla panchina bianconera, siede Thiago Motta. Giuntoli ha rivoluzionato la rosa. In...
Siamo al termine del 2024. Un anno, sportivamente parlando, piuttosto intenso per chi vive con DNA bianconero. È successo di tutto. Non c’è più Allegri ma ora, sulla panchina bianconera, siede Thiago Motta. Giuntoli ha rivoluzionato la rosa. In...
 Come già accennato un paio di mesi fa su queste colonne elettroniche, gli osservatori bianconeri seguiranno nuovamente Niccolò Fortini e lo faranno nel match odierno della Juve Stabia contro la Reggiana. Il polivalente esterno classe 2006, che può giocare...
Come già accennato un paio di mesi fa su queste colonne elettroniche, gli osservatori bianconeri seguiranno nuovamente Niccolò Fortini e lo faranno nel match odierno della Juve Stabia contro la Reggiana. Il polivalente esterno classe 2006, che può giocare...
 Juve impegnata domenica sera a Monza. Dopo il successo in Coppa Italia, serve una svolta anche in campionato, per...
Juve impegnata domenica sera a Monza. Dopo il successo in Coppa Italia, serve una svolta anche in campionato, per...



 Andrea Bosco ha lavorato al “Guerin Sportivo“, alla “Gazzetta dello Sport“, al “Corriere d'Informazione”, ai Periodici Rizzoli, al “Giornale“, alla Rai e al Corriere della Sera.
Andrea Bosco ha lavorato al “Guerin Sportivo“, alla “Gazzetta dello Sport“, al “Corriere d'Informazione”, ai Periodici Rizzoli, al “Giornale“, alla Rai e al Corriere della Sera.
 Alessandro Del Piero ha detto la sua sulla Juventus ai microfoni di Sky Sport. Tuttojuve.com ha sintetizzato il suo intervento: "Le aspettative sono quelle che sono, le mie personali quando penso alla Juventus sono sempre molto alte, perchè lo dice la storia. Poi...
Alessandro Del Piero ha detto la sua sulla Juventus ai microfoni di Sky Sport. Tuttojuve.com ha sintetizzato il suo intervento: "Le aspettative sono quelle che sono, le mie personali quando penso alla Juventus sono sempre molto alte, perchè lo dice la storia. Poi...
 E’ online da oggi il singolo "Calci a un pallone", cantato da Barbara Bonansea, Cristiana Girelli e Martina Rosucci: le tre calciatrici sono le protagoniste di un progetto benefico il cui ricavato andrà a favore delle bambine dello Ski Lanka,...
E’ online da oggi il singolo "Calci a un pallone", cantato da Barbara Bonansea, Cristiana Girelli e Martina Rosucci: le tre calciatrici sono le protagoniste di un progetto benefico il cui ricavato andrà a favore delle bambine dello Ski Lanka,...
 La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, informa i tifosi bianconeri su dove vedere il match del campionato Primavera che i bianconeri giocheranno domani, a partire dalle 13:00, contro l'Atalanta a Zingonia:
U20 | ATALANTA-JUVENTUS, DOVE VEDERLA
"La...
La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, informa i tifosi bianconeri su dove vedere il match del campionato Primavera che i bianconeri giocheranno domani, a partire dalle 13:00, contro l'Atalanta a Zingonia:
U20 | ATALANTA-JUVENTUS, DOVE VEDERLA
"La...
 14:22 - IL REPORT DELL'ALLENAMENTO - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha fornito i dettagli della sedute odierna: "Juventus in campo, a Santo Stefano, dopo i due giorni di riposo concessi da Thiago Motta. Al Training Center i bianconeri...
14:22 - IL REPORT DELL'ALLENAMENTO - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha fornito i dettagli della sedute odierna: "Juventus in campo, a Santo Stefano, dopo i due giorni di riposo concessi da Thiago Motta. Al Training Center i bianconeri...
 La partita con il City è cambiata con due episodi, il primo Di Gregorio che salva su Haaland nel primo tempo e nel secondo la cavalcata di Federico Gatti che rompe gli schemi e fa ripartire la Juve innescando poi l'azione che porta al gol.
ROMPERE GLI...
La partita con il City è cambiata con due episodi, il primo Di Gregorio che salva su Haaland nel primo tempo e nel secondo la cavalcata di Federico Gatti che rompe gli schemi e fa ripartire la Juve innescando poi l'azione che porta al gol.
ROMPERE GLI...