Gli eroi in bianconero: Luigi ALLEMANDI

«Era una forza scatenata della natura. – scrive Sergio Di Battista su “La Storia della Juventus” – Portava la zazzera ricciuta e aveva del diavolo. I suoi spunti veloci impressionavano come i suoi balzi acrobatici, Entrava primo sull’avversarlo lanciato al gol ed erano veri sfracelli. Se poi gli toccavano il Pepp Meazza nell’area opposta, partiva lui digrignando a render noto che un altro colpo sarebbe stato restituito con ingenti interessi». Così Gianni Brera racconta Luigi Allemandi, detto Gigi, classe 1903, nato a pochi chilometri da Cuneo, campione del mondo, compagno di Eraldo Monzeglio in una di quelle celebri coppie di terzini immortalate nel gran libro delle leggende. Prima c’erano Rosetta e Caligaris, poi sarebbero venuti Foni e Rava. E ancora Burgnich-Facchetti, Gentile-Cabrini...
Come Burgnich, anche Allemandi fu di passaggio alla Juventus prima di approdare ai fasti di un mondiale sotto altri colori societari, curiosamente sempre gli stessi, quelli dell’Inter.
In maglia bianconera Allemandi visse due stagioni, il tempo di vincere uno scudetto e di diventare un caso nazionale, legato allo scandalo più famoso dei nostri campionati, quello che gli albi d’oro ricordano con un sibillino: Torino sette titoli più uno revocato.
Erano i tempi di «profumi e balocchi». Nel Genoa giocata un altro terzino, Renzo De Vecchi, dal soprannome vagamente ambizioso: «il figlio di Dio».
Lo scudetto, nella Juve, Allemandi lo vinse subito. Aveva poco più di vent’anni ed era già un veterano. In serie A – la serie A di allora, nella quale giocavano anche l’Esperia e la Rivarolese – aveva debuttato con i colori del Legnano: in occasione di una memorabile vittoria sulla Juventus aveva anche segnato un gol, su rigore, a Combi, suo futuro compagno. Uno dei rari gol di una lunga carriera sotto molte bandiere. Partì titolare, prima a fianco di Gianfardoni (lo avrebbe ritrovato nell’Ambrosiana), poi del grande Rosetta, infine di Ferrero.
Che lo facessero giocare a destra o a sinistra, per lui era indifferente, sapeva battersi con la stessa classe. Scatto straordinario, lunghe respinte che spesso si trasformavano in rilanci per l’attacco, soprattutto tanta grinta.
Il pasticciaccio arrivò l’anno successivo, nell’estate del 1927, con la Juve impegnata a difendere il suo scudetto nel girone finale del torneo, tra rivali di gran nome, il Bologna e il Genoa, l’Inter, il Milan e il Torino.
Accadde proprio in occasione del derby. Allemandi ne avrà parlato mille volte prima di morire, sulla soglia dei settantacinque, a Pietra Ligure, dove si era messo a fare il rappresentante di commercio: «Abitavo in una pensione della piazzetta Madonna degli Angeli. Studiavo legge, mio padre era notaio. La Juve mi dava 400 lire al mese, mi bastavano...».
Quelli del Torino gliene offrirono cinquantamila per favorire la loro vittoria. Avrebbe potuto comprarsi cinque «Balilla» appena uscite dalla Fiat.
«Già nella partita di andata, che avevamo vinto uno a zero – raccontava – c’era stato del losco. Il geometra Monateri, dirigente bianconero, ci aveva avvertito: sapeva che qualcuno aveva tentato di comprare dei giocatori della Juve. State in gamba, disse, se vi pesco siete finiti».
Venticinquemila, si dice, le prese subito. O meglio le prese uno studente del politecnico, amico e coinquilino, che agiva da intermediario. Il resto sarebbe venuto dopo la partita. Allemandi, invece, giocò troppo bene per meritarsi tutto il premio della corruzione. E benché avesse vinto (due a uno, primo tempo in svantaggio, pareggio su rigore per un fallo che non fu di Allemandi) il Torino si rifiutò di saldare il conto a quel reprobo che, in realtà, era stato uno dei migliori in campo.
La vicenda, a questo punto, cominciò a diventare un «giallo» vero e proprio con gli investigatori della Federcalcio che frugavano nei cestini della pensione di piazza Madonna degli Angeli. Qui, si diceva, in un’atmosfera da amore e ginnastica, presenti lo studente e un giornalista romano, era maturato lo scellerato patto. Qualcuno aveva orecchiato al muro e saltarono persino fuori i frammenti di una lettera nella quale il giocatore reclamava il suo credito. Non mancarono contorni grotteschi: la storia fu addebitata all’eccesso di zelo di alcuni dirigenti del Torino, che avevano saputo di una innocente – quella sì – scommessa tra i presidenti delle due società, Edoardo Agnelli e il conte Marone, in palio nientemeno che una cena, ospite il principe di Piemonte.
Al Torino fu tolto lo scudetto, Allemandi venne squalificato a vita. Quando arrivò la sentenza, dopo un’istruttoria durata quattro mesi, il giocatore aveva già lasciato la Juventus. Era stato ceduto all’Ambrosiana-Inter.
Rimase lontano dai campi solo un anno. Venne la grazia (per lui, ma non per il Torino), chiesta dalla madre con una lettera toccante e favorita dall’euforia per i successi della Nazionale all’Olimpiade di Amsterdam. Gli ambienti del palazzo continuarono a sostenere che le prove dell’inchiesta erano state schiaccianti.
Negli anni, lui, il vecchio terzino che aveva spaventato due generazioni di attaccanti, avrebbe continuato a ripetere, scuro in volto, con quel suo eterno cruccio in fondo al cuore: «Cose vecchie, cose vecchie. C’è stato del marcio, è vero, ma il responsabile non sono io. Sono stati altri. Ho cercato invano chi avrebbe potuto scagionarmi: è morto».
VLADIMIRO CAMINITI
Storia di un campione che non fu mai capito, si potrebbe intitolare il suo personaggio. «Faceva paura, era un pazzo favoloso», dice di lui Farfallino Borel con nostalgia. E aggiunge: «Era anche un grosso personaggio». In realtà, fu un grandissimo terzino.
Forte come una compagnia di fanti animati dal così detto ideale, spazzò intrepidamente e fu il migliore in campo nel derby Torino-Juventus 2-1 del 5 giugno 1927 al campo di Corso Marsiglia che doveva calamitargli addosso la prima inchiesta federale del romanzo del calcio, difendendosi con il comportamento in campo ma non bastando davanti all’evidenza di accordi presi nella stessa pensione dove alloggiava con emissari del Torino che forse temevano la caparbietà di questo campione coraggioso sul serio, che non si aiutava gridando come faceva Berto Caligaris, ma a tutto campo spezzava e spazzava, con pedate possenti che rompevano peroni, in tempi in cui i giocatori andavano in campo con parastinchi tripli e si menava gloriosamente e poi si scherzava sui menati e chi si tirava indietro era un vile e questo fu il calcio radioso della Madama anni Trenta, stile ma anche animalità, virulenza, il presunto barone Mazzonis non perdonando una licenza poetica e zittendo col suo prestigio, che gli derivava dal fatto di poter disporre della piena fiducia di Edoardo Agnelli, anche i Combi e Rosetta.
Vestì ventisei maglie azzurre, ventiquattro da moschettiere, esordendo a Padova contro la Jugoslavia in coppia con Bellini, Schiavio centravanti, lo sterminato dribblatore Cevenini III detto Zizì mezzala sinistra, contendendo la maglia al più appariscente Berto Caligaris, che lo aveva sostituito alla Juve dopo il fattaccio, fu protagonista dei memorabili match della primavera 1932 a Parigi e Budapest contro Francia e Ungheria, rilevato poi dal bolognese Gasperi e dall’irriducibile Caligaris, tornava in Nazionale contro la Grecia nell’aprile del 1934 in tempo per essere preso in considerazione, come terzino dell’Ambrosiana, per la prima conquista storica del nostro calcio: il campionato del mondo organizzato dal PNM con tutti i fori cadenti dell’antica romanità convocati sul posto e comandati di fare da cornice.
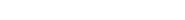





 Siamo al termine del 2024. Un anno, sportivamente parlando, piuttosto intenso per chi vive con DNA bianconero. È successo di tutto. Non c’è più Allegri ma ora, sulla panchina bianconera, siede Thiago Motta. Giuntoli ha rivoluzionato la rosa. In...
Siamo al termine del 2024. Un anno, sportivamente parlando, piuttosto intenso per chi vive con DNA bianconero. È successo di tutto. Non c’è più Allegri ma ora, sulla panchina bianconera, siede Thiago Motta. Giuntoli ha rivoluzionato la rosa. In...
 Come già accennato un paio di mesi fa su queste colonne elettroniche, gli osservatori bianconeri seguiranno nuovamente Niccolò Fortini e lo faranno nel match odierno della Juve Stabia contro la Reggiana. Il polivalente esterno classe 2006, che può giocare...
Come già accennato un paio di mesi fa su queste colonne elettroniche, gli osservatori bianconeri seguiranno nuovamente Niccolò Fortini e lo faranno nel match odierno della Juve Stabia contro la Reggiana. Il polivalente esterno classe 2006, che può giocare...
 Juve impegnata domenica sera a Monza. Dopo il successo in Coppa Italia, serve una svolta anche in campionato, per...
Juve impegnata domenica sera a Monza. Dopo il successo in Coppa Italia, serve una svolta anche in campionato, per...



 Andrea Bosco ha lavorato al “Guerin Sportivo“, alla “Gazzetta dello Sport“, al “Corriere d'Informazione”, ai Periodici Rizzoli, al “Giornale“, alla Rai e al Corriere della Sera.
Andrea Bosco ha lavorato al “Guerin Sportivo“, alla “Gazzetta dello Sport“, al “Corriere d'Informazione”, ai Periodici Rizzoli, al “Giornale“, alla Rai e al Corriere della Sera.
 La Juventus, tornata alla vittoria in campionato, prepara la sfida contro la Fiorentina ma guarda anche al mercato. Cristiano Giuntoli è al lavoro per rinforzare la rosa, e il nome in cima alla lista per la difesa è quello di Antonio Silva.
Il giovane...
La Juventus, tornata alla vittoria in campionato, prepara la sfida contro la Fiorentina ma guarda anche al mercato. Cristiano Giuntoli è al lavoro per rinforzare la rosa, e il nome in cima alla lista per la difesa è quello di Antonio Silva.
Il giovane...
 E’ online da oggi il singolo "Calci a un pallone", cantato da Barbara Bonansea, Cristiana Girelli e Martina Rosucci: le tre calciatrici sono le protagoniste di un progetto benefico il cui ricavato andrà a favore delle bambine dello Ski Lanka,...
E’ online da oggi il singolo "Calci a un pallone", cantato da Barbara Bonansea, Cristiana Girelli e Martina Rosucci: le tre calciatrici sono le protagoniste di un progetto benefico il cui ricavato andrà a favore delle bambine dello Ski Lanka,...
 La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, informa i tifosi bianconeri su dove vedere il match del campionato Primavera che i bianconeri giocheranno domani, a partire dalle 13:00, contro l'Atalanta a Zingonia:
U20 | ATALANTA-JUVENTUS, DOVE VEDERLA
"La...
La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, informa i tifosi bianconeri su dove vedere il match del campionato Primavera che i bianconeri giocheranno domani, a partire dalle 13:00, contro l'Atalanta a Zingonia:
U20 | ATALANTA-JUVENTUS, DOVE VEDERLA
"La...
 14:22 - IL REPORT DELL'ALLENAMENTO - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha fornito i dettagli della sedute odierna: "Juventus in campo, a Santo Stefano, dopo i due giorni di riposo concessi da Thiago Motta. Al Training Center i bianconeri...
14:22 - IL REPORT DELL'ALLENAMENTO - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha fornito i dettagli della sedute odierna: "Juventus in campo, a Santo Stefano, dopo i due giorni di riposo concessi da Thiago Motta. Al Training Center i bianconeri...
 La partita con il City è cambiata con due episodi, il primo Di Gregorio che salva su Haaland nel primo tempo e nel secondo la cavalcata di Federico Gatti che rompe gli schemi e fa ripartire la Juve innescando poi l'azione che porta al gol.
ROMPERE GLI...
La partita con il City è cambiata con due episodi, il primo Di Gregorio che salva su Haaland nel primo tempo e nel secondo la cavalcata di Federico Gatti che rompe gli schemi e fa ripartire la Juve innescando poi l'azione che porta al gol.
ROMPERE GLI...