Gli eroi in bianconero: Paolo DI CANIO

Tutto cominciò con un polsino – scrive Francesca Sanipoli sul “Guerin Sportivo” del 18 luglio 1990 –. Fu dopo una partita col Cesena che Paolo Di Canio se lo strappò e lo lanciò in aria con rabbia: «Era soltanto un gesto di disappunto, non c’era polemica, non era indirizzato verso nessuno» ricorda «ma fu sufficiente per nascere un caso. Nel giro di poche ore si parlò di rimandarmi a giocare nella Primavera della Lazio, di farmi una multa di dieci milioni... È stato allora che ho capito che era venuto il momento di cambiare aria».
Ventidue anni appena compiuti (è nato luglio, come Adriano Panatta e Gianluca Vialli), Paolo Di Canio si ritrova alla Juve, la stessa squadra nella quale giocheranno Baggio e Schillaci, due nomi carichi di significato. Una fortuna o una disgrazia? «Certamente una fortuna, anche se ci sarà da faticare per trovare un posto in squadra. Ma io sono uno che a tennis si sceglie sempre l’avversario più forte, altrimenti non mi diverto. E poi, con tutti i campioni che ci saranno nella mia nuova squadra, finalmente non sarò più il principale oggetto delle pressioni dei tifosi, della stampa e della società».
La decisione era nell’aria da molto tempo, ma lui ha aspettato a lungo prima di comunicarla ufficialmente: «È stato un periodo durissimo. Stavano succedendo cose più grosse di me e non sapevo come gestirle. La gente voleva sapere, ed io non riuscivo a ragionare freddamente. Finalmente ho deciso di andarmene da Roma, per tanti motivi. Ho amato la Lazio, la amo e l’amerò sempre. Ma come calciatore ho anche bisogno di giocare in una squadra nella quale potenzialmente posso togliermi delle soddisfazioni. Se la Juve mi ha voluto, credo di avere dei meriti anch’io: forse non sono soltanto il ragazzino immaturo su cui gravavano, negli ultimi tempi in biancazzurro, tante pressioni e responsabilità. Se una società così seria prende un giocatore, deve aver avuto delle buone referenze. Ed io, in questo momento, ho un enorme bisogno di credibilità, di fiducia, di stimoli. Tutte cose che la Juve può darmi. Oltre, beninteso, a qualche vittoria: con Baggio, Schillaci, De Agostini, Tacconi e tutti gli altri campioni che ci sono, spero di vincere subito uno scudetto. Anche se dovrò rinunciare a essere considerato una bandiera...».
Già: non molto tempo prima dell’addio aveva dichiarato che sarebbe andato via dalla Lazio soltanto se fosse stata la società a cederlo: «Dopo il famoso gesto del polsino, in effetti, lo stesso presidente Calleri mi disse che mi considerava ancora immaturo per essere la bandiera di una squadra. Ho commesso degli errori, è vero. Mi sono troppo spesso lasciato guidare dall’istinto, in mancanza dell’esperienza. Ma tutto sommato credo di aver fatto anche qualcosa di buono. Essere il primo della classe è molto gratificante, ma non è sempre facile. A volte può essere estremamente scomodo, e anche pericoloso, soprattutto per un giovane come me. E allora voglio godermi fino in fondo questa nuova sfida, una sfida importantissima, una grande fortuna che mi è capitata e che spero di non bruciare».
Secondo i maligni, Di Canio – pallino di Montezemolo – avrebbe preso, oltre all’ingaggio, una sorta di «sottobanco» per dire di sì alla Juve: «È chiaro che un giocatore professionista, quando cambia squadra, cerchi di fare soprattutto un salto di qualità. Ma, come in tutti i mestieri del mondo, credo che sia importante anche ottenere dei vantaggi economici. Non nego che alla Juve vado a guadagnare di più: il mio ingaggio in bianconero sarà circa il quadruplo di quello che percepivo alla Lazio. Francamente non credo ci fosse bisogno di “sottobanco” per convincermi».
Aveva detto, però, che pur di restare alla Lazio sarebbe stato disposto a guadagnare di meno rispetto alle sue potenzialità: «Quando lo dissi ero in assoluta buona fede: fu subito dopo il derby, un momento molto particolare, per me. Poi, però, ho capito che se fossi rimasto avrei rischiato di darmi la zappa sui piedi. Giocare con la maglia della Juve è la massima aspirazione per un campione, figuriamoci per un ragazzino come me. Lascio un ruolo di leader, ma ho la possibilità di guadagnarmi un posto in una delle squadre più prestigiose del mondo».
E come pensa di vivere il passaggio dallo stile-Lazio allo stile-Juve? «La Lazio è una squadra giovanissima: questa presidenza esiste da quattro anni ma è soltanto al terzo di Serie A. Un paragone con la tradizione e la storia della Juve non è proponibile: sarà tutta un’altra cosa. Spero soltanto di esserne all’altezza».
Con i vecchi e nuovi acquisti, la Juventus è tra le favorite del prossimo campionato: «Sono d’accordo, ma ci andrei piano: ricordo ancora quando si diceva che Sacchi non sarebbe arrivato a mangiare il panettone e poi, invece, il Milan fece un recupero strabiliante. Sulla carta la Juve è la favorita, è vero. Ma ci sono Inter, Milan, Napoli, Sampdoria che possono fare qualunque cosa. Con la Juve ho un contratto quadriennale, ma a essere sincero spero di rimanerci molto più a lungo: dopo la Lazio, per la quale ho fatto il tifo in curva, da bambino, la Juve è sempre stata la mia squadra del cuore. Le ho sempre invidiato i campioni come Platini, la classe, tutti gli scudetti che ha vinto...».
Ma non c’è proprio nulla, di quella che a suo tempo ha definito «una scelta di vita», a spaventarlo? «No: sono un tipo estroverso, è difficile che possa avere problemi di inserimento, almeno per quanto riguarda l’aspetto umano. Certo, mi mancheranno le ottobrate romane, avrò nostalgia della mia famiglia e della mia ragazza, Elisabetta, che vive a Terni. Ma per fortuna esistono gli aerei...».
E gli mancherà il derby, un derby vissuto anche in famiglia, con suo fratello Antonio che gioca nel Quarticciolo e tifa Roma, da sempre: «Malgrado sia passato al nemico per eccellenza, però, mio fratello è stato felicissimo per me. Per il mio compleanno mi ha regalato un cuscino con su scritto: “complimenti, ce l’hai fatta”. Sapeva quanto fosse importante, per me, una svolta del genere a questo punto della carriera».
Del derby vissuto in campo ricorda quel famoso 26° del primo tempo quando, il 19 gennaio del 1989, infilò il pallone nella rete della Roma: «Vedevo realizzarsi un sogno coltivato fin da piccolissimo. Prima di quel derby, che a Roma tornava dopo tre anni di esilio laziale, mi ero chiuso in bagno a riflettere».
Si era anche fatto crescere il «pizzetto», come aveva fatto Borg per cinque anni consecutivi a Wimbledon: «Dopo quel gol persi la testa dalla felicità. Avevo giurato a Rizzolo che, se avessi segnato, sarei andato sotto la curva Nord».
Ma poi, in uno scarico di adrenalina, aveva cambiato direzione, precipitandosi verso quella della Roma, l’indice della mano destra puntato verso l’alto. Come Chinaglia. Come Mennea. «Gestacci? No, soltanto la gioia di un ragazzino che tocca il cielo, è proprio il caso di dirlo, con un dito. E poi, non può essere fatta di gestacci la rivincita di uno che tre anni prima aveva rischiato di perdere l’uso di un piede».
Una tallonite mal curata, quand’era alla Ternana: «Quando avevo 15 anni nessuno mi prendeva sul serio. Dopo l’allenamento schizzavo subito in piazzetta, al Quarticciolo. A casa ci andavo soltanto per mangiare. Ho cominciato a capire qualcosa quando ho visto piangere mia madre, in ospedale: il problema non era tanto tornare a giocare, quanto salvare il piede. Quando sentii mamma dire sottovoce che del pallone non le importava, che la sola cosa che contasse era che non rimanessi zoppo, improvvisamente diventai grande. Quel ricordo me lo porterò sempre dentro, mi aiuterà a rimanere umile, mi darà la forza per lottare. Anche se si trattasse di combattere per ottenere un posticino in una grande squadra. Come la Juve».
Racconta il giorno del raduno: «Mi sono detto che se la società bianconera continuava a seguirmi, credeva in me non solo dal punto di vista tecnico, capivano il Di Canio ragazzo più che giocatore, allora dovevo tentare. Che emozione il giorno in cui strinsi la mano dell’avvocato Agnelli! Ora so che rischio in prima persona, non sarà facile trovare un posto in una squadra di grandi campioni. Ma nell’ultimo campionato con la Lazio ho dimostrato di poter giocare non solo da tornante ma pure da seconda punta, mi sono divertito molto, segnando anche tre gol, uno proprio alla Juve. Abbandono la mia città, Roma, lascio una ragazza a Terni per vivere da solo a Torino. Mi sembra che la dica lunga sulle mie intenzioni. Vivo un momento bellissimo, vorrei giocare molto, so che naturalmente non dipenderà solo da me. Non mi sento un raccomandato di Maifredi, perché il tecnico continua a elogiarmi. Sono contento della sua stima così come di quella della società. Ho ritrovato fiducia e serenità, al punto che tornerò a Roma tranquillo. Contro i giallorossi no, non sarà derby, anzi finalmente potrò dormire la notte prima della partita e sperare di segnare un gol, un ultimo regalo alla curva biancoceleste. E contro la Lazio, beh, mi sembrerà strano non indossare quei colori, ma l’unica cosa che potrebbe farmi star male sono i fischi, non credo di essere un traditore».
Ma nella rosa oltre a Paolo, ci sono Hässler, Baggio, Schillaci, tutti giocatori troppo individualisti per poter coesistere. Amano ricevere la palla al piede per poi lanciarsi in azioni personali e ci vorrebbero quattro o cinque palloni contemporaneamente per poterli accontentare tutti. Senza dimenticare che la squadra è molto sbilanciata e Tacconi è costretto a passare parecchi brutti momenti. Va da sé che la stagione non può finire bene e anche Di Canio finisce nell’occhio del ciclone.
L’anno successivo, con Trapattoni, malgrado qualche iniziale mugugno, Di Canio ritrova entusiasmi e stimoli. Della curva juventina, quella dedicata al fuoriclasse del calcio e della vita Gaetano Scirea, è un beniamino. I sostenitori bianconeri si riconoscono in lui, nella sua genuinità, in quel suo essere privo di maschere e reticenze. E lui ricambia tanto affetto piroettando sul campo, con quel suo modo sudamericaneggiante di intendere e interpretare il football. «In me è cambiato tutto, sono cresciuto e ci sono riuscito, perché nessuno mi ha messo fretta. Si trattava solo di aspettare, di avere pazienza e con me ne hanno sempre avuta poca».
VITTORIO OREGGIA, DA “HURRÀ JUVENTUS” DEL NOVEMBRE 1992
C’è una cosa che lo fa arrabbiare: sentirsi descrivere come una testa matta. Se la prende, Paolo Di Canio, perché questa etichetta appartiene al passato e, in un certo senso, non è mai stata aderente alla realtà. In assoluto, comunque, l’ex ragazzino terribile del Quarticciolo, nemico dichiarato della Roma giallorossa, amico ritrovato della Juventus, ha cambiato pelle. Il merito è di due donne, le sue donne: la moglie Elisabetta e la piccola Ludovica. Così, stregato dal fascino delle sue signore, Paolo il caldo ha raffreddato certi entusiasmi per la vita spericolata. Ma questa metamorfosi non gli impedisce di andare al massimo: «Sono sempre me stesso. Chiedetelo a quei poveretti dei miei compagni, vittime di scherzi terribili». Sacrosanta verità.
Non a caso, Di Canio ha legato subito con Vialli, l’altro mattacchione dello spogliatoio juventino. Luca crapa pelata ha fatto proseliti, tanto che anche Paoletto ha deciso di tagliarsi i capelli a zero. Uno skinhead in piena regola, ma solo nel look un po’ trasgressivo. Perché dietro la voglia di scherzare e il desiderio di sdrammatizzare ci sono consapevolezze importanti. I famosi valori, per esempio: «Strada facendo, sbagliando e correggendomi, ho imparato a prendere la vita per il verso giusto. Ho capito che la famiglia è tutto. Perché in famiglia c’è armonia e con l’armonia c’è la tranquillità. Ingredienti fondamentali per emergere».
Ecco, Elisabetta e Ludovica, le sue donne. Di Canio è stato a lungo sull’orlo di una crisi di nervi. Era persino arrivato al punto di pensare al divorzio, alla rottura del rapporto con la Juve. Una storia vecchia, passata. Anzi, sorpassata: «Non diamo a una situazione delicata i contorni di un dramma. Non ero soddisfatto di star fuori, a guardare gli altri. Ma chiunque lo sarebbe stato. Trapattoni mi raccomandava di avere pazienza e non riuscivo a capirlo. Invece sbagliavo. Me ne sono reso conto dopo. Il fatto è che la mia carriera è sempre stata esagerata. A diciannove anni ero titolare della Lazio, un perenne osservato speciale. Ed io non avevo pazienza per aspettare ma neppure gli altri ne avevano per aspettare me. Quando si è giovani si sbaglia. Ed ho sbagliato. Ma mi sono ripreso».
Si è ripreso la maglia titolare, soprattutto. Le ultime prestazioni della scorsa stagione e il convincente inizio di campionato hanno spinto il Trap a confermarlo sul fronte offensivo. Di Canio è rinato poco a poco, anche se nessuno gli ha regalato nulla: «Quest’estate, mentre gli altri compagni si divertivano in spiaggia, sono andato in Calabria a lavorare con il dottor Bergamo. Ogni giorno mi sottoponevo a una cura intensiva di sudore. Il potenziamento muscolare, comunque, ha dato i suoi frutti. Ho messo qualche chilo, non sono più una piuma: per buttarmi a terra ci vuole una spallata. E l’arbitro fischia il fallo. Dettagli, la cura dei dettagli. Trapattoni sembra un maniaco, ma se insiste sui dettagli una ragione deve pur esserci, no?».
Non è più quello di una volta, Di Canio. Ha accantonato le inutili leziosità che tanto facevano infuriare il Trap ed ha messo la sua classe al servizio della squadra. Un’evoluzione tecnica, tattica, personale. Adesso Paolo il caldo è un freddo ragionatore: «Ho conservato qualche tocco, il gusto per il dribbling, la passione per le fughe inebrianti sulla fascia destra. Nel contempo ho capito che non bisogna esagerare. E devo confessare che Trapattoni ha svolto un ruolo fondamentale nella mia maturazione».
Con la Curva Scirea ha stretto un legame basato sulla reciproca simpatia. Non c’è partita in cui la frangia più accesa dei sostenitori bianconeri non scandisca semplicemente il nome o non componga un coro in favore di Di Canio. Retaggio di una passione lontana: «Ero un ultrà della Lazio. Andavo in trasferta con poche lire in tasca e non avevo paura di nulla. Ho provato cosa significa soffrire per una sconfitta o vivere una partita in curva: ecco perché, forse, oggi i tifosi juventini mi vogliono bene. In fondo, io sono uno di loro. Un innamorato della Signora».
Dicono che sia un bisbetico domato. Dice che il suo peggior difetto è l’istintività e il suo miglior pregio è la disponibilità. Dice che ha quasi pianto quando ha saputo che avrebbe giocato la prima finale di Coppa Italia con il Parma. Insomma, un ragazzo semplice a cui piacciono le cose semplici. E non dite che è una testa matta. Al massimo lo era.
Comincia la terza stagione juventina con buoni propositi, nonostante gli spazi si restringano con l’arrivo di Vialli e Ravanelli. «Eravamo a Villar Perosa una domenica mattina – racconterà anni dopo – era una novità per me che ero giovane e appena arrivato alla Juventus. Una villa enorme, un posto magnifico. Ci fecero restare per più di mezzora in quel cortile e vedevo attorno a me una certa tensione anche sul volto di grandissimi campioni come Baggio. A quel punto mi preoccupai, perché volevo far bella figura davanti a un personaggio così importante. A un certo punto si sentì il rumore delle pale dell’elicottero e atterrò tra noi l’Avvocato. Parlò molto con Trapattoni ed io, che ero lì vicino, ascoltai alcune parole. “Lo farai giocare Di Canio?” chiese al Trap. Il nostro allenatore rispose negativamente “Abbiamo bisogno di più copertura a centrocampo contro i mediani dell’Udinese”. Allora l’Avvocato fece una delle sue meravigliose battute “Di Canio è come lo champagne, tutti vogliono le bollicine alla fine di un pasto”. Allora mi sentì ringalluzzito da tanta considerazione. Ma l’Avvocato andò oltre: “Quando Di Canio entra in area e c’è un difensore avversario sono contento, perché molto probabilmente per fermarlo saranno costretti a fargli un fallo da rigore”. Ero tanto sorridente in quel momento, a sentire queste parole, ma ecco che l’ultima parte del suo discorso mi distrusse: “Quando invece entra in area e non ci sono difensori avversari mi preoccupo, perché chissà dove manderà quel pallone”. Su questa battuta i compagni mi presero in giro per un anno intero. Effettivamente era il fantastico stile dell’avvocato, ironico e dissacrante. È qualcosa che mi manca tantissimo in questo calcio di oggi, qualcuno col suo acume. In mezzo ai dirigenti sciatti di oggi servirebbe così tanto uno come lui».
Ma Di Canio è un personaggio irrequieto ed ha qualche incomprensione di troppo con l’allenatore di Cusano Milanino. Così, dopo aver vinto la Coppa Uefa edizione 1992-93, chiede di essere ceduto e si trasferisce a Napoli. «È da un mese che ho deciso di andar via. Io qui non ci posso più stare», afferma il giorno dell’addio.
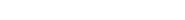





 Nessuna telefonata di Moggi con gli arbitri. Nessuna partita alterata. Chi indossa il nostro scudetto e lo mette in mostra con una copia, ha raggiunto il punto più basso di etica sportiva.
Nessuna telefonata di Moggi con gli arbitri. Nessuna partita alterata. Chi indossa il nostro scudetto e lo mette in mostra con una copia, ha raggiunto il punto più basso di etica sportiva.
 Secondo indiscrezioni raccolte da Tuttojuve.com, uno dei nomi accostati nuovamente ai bianconeri è quello di Danylo Sikan (23) dello Shakhtar Donetsk. L'attaccante, però, non stuzzica le idee della dirigenza bianconera, che sul fronte attaccanti potrebbe...
Secondo indiscrezioni raccolte da Tuttojuve.com, uno dei nomi accostati nuovamente ai bianconeri è quello di Danylo Sikan (23) dello Shakhtar Donetsk. L'attaccante, però, non stuzzica le idee della dirigenza bianconera, che sul fronte attaccanti potrebbe...
 Juve impegnata domenica sera a Monza. Dopo il successo in Coppa Italia, serve una svolta anche in campionato, per...
Juve impegnata domenica sera a Monza. Dopo il successo in Coppa Italia, serve una svolta anche in campionato, per...



 Andrea Bosco ha lavorato al “Guerin Sportivo“, alla “Gazzetta dello Sport“, al “Corriere d'Informazione”, ai Periodici Rizzoli, al “Giornale“, alla Rai e al Corriere della Sera.
Andrea Bosco ha lavorato al “Guerin Sportivo“, alla “Gazzetta dello Sport“, al “Corriere d'Informazione”, ai Periodici Rizzoli, al “Giornale“, alla Rai e al Corriere della Sera.
 Il Napoli avrebbe praticamente chiuso con il Lecce la trattativa per la cessione a titolo definitivo del cartellino di Luis Hasa, trequartista classe 2004 cresciuto nelle giovanili della Juventus. Come riportato da "Calciomercato.com", l'accordo tra le parti...
Il Napoli avrebbe praticamente chiuso con il Lecce la trattativa per la cessione a titolo definitivo del cartellino di Luis Hasa, trequartista classe 2004 cresciuto nelle giovanili della Juventus. Come riportato da "Calciomercato.com", l'accordo tra le parti...
 Il colosso dello streaming Netflix ha deciso di entrare in maniera importante nel mondo del calcio. Come annunciato in un comunicato infatti è stato raggiunto uno storico accordo con la FIFA per i diritti in esclusiva per gli Stati Uniti d’America per le...
Il colosso dello streaming Netflix ha deciso di entrare in maniera importante nel mondo del calcio. Come annunciato in un comunicato infatti è stato raggiunto uno storico accordo con la FIFA per i diritti in esclusiva per gli Stati Uniti d’America per le...
 La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, informa i tifosi bianconeri su dove vedere il match del campionato Primavera che i bianconeri giocheranno domani, a partire dalle 13:00, contro l'Atalanta a Zingonia:
U20 | ATALANTA-JUVENTUS, DOVE VEDERLA
"La...
La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, informa i tifosi bianconeri su dove vedere il match del campionato Primavera che i bianconeri giocheranno domani, a partire dalle 13:00, contro l'Atalanta a Zingonia:
U20 | ATALANTA-JUVENTUS, DOVE VEDERLA
"La...
 15:22 - ALLENAMENTO IN CORSO - La Juventus è in campo e si sta allenando in vista del match contro il Monza.
14:50 - A BREVE JUVE IN CAMPO - A breve la Juventus sarà in campo per allenarsi in vista della gara contro il Monza. In questa...
15:22 - ALLENAMENTO IN CORSO - La Juventus è in campo e si sta allenando in vista del match contro il Monza.
14:50 - A BREVE JUVE IN CAMPO - A breve la Juventus sarà in campo per allenarsi in vista della gara contro il Monza. In questa...
 La partita con il City è cambiata con due episodi, il primo Di Gregorio che salva su Haaland nel primo tempo e nel secondo la cavalcata di Federico Gatti che rompe gli schemi e fa ripartire la Juve innescando poi l'azione che porta al gol.
ROMPERE GLI...
La partita con il City è cambiata con due episodi, il primo Di Gregorio che salva su Haaland nel primo tempo e nel secondo la cavalcata di Federico Gatti che rompe gli schemi e fa ripartire la Juve innescando poi l'azione che porta al gol.
ROMPERE GLI...