Gli eroi in bianconero: Marino MAGRIN

È stato sfortunato, Marino Magrin: capitato in una delle peggiori Juventus di sempre (quella di Marchesi, tanto per intendersi) e costretto a sostituire, nel gioco e nel cuore dei tifosi, Michel Platini. Chiunque avrebbe capito che l’ex atalantino non sarebbe mai stato in grado di rimpiazzare il divino Michel. Dotato di buona tecnica e temibile sui calci piazzati, il buon Magrin ci prova, soprattutto il primo anno: trentaquattro presenze e sei gol, che gli valgono la riconferma per la stagione successiva, che lo vede partire spesso dalla panchina anche se, alla fine, totalizzerà trenta presenze e due reti. Ma l’avventura juventina di Marino finisce qui: la sensazione è che, magari in un’altra Juventus, avrebbe potuto recitare un ruolo da protagonista.
NICOLA CALZARETTA, DAL “GUERIN SPORTIVO” DEL 3-9 NOVEMBRE 2009
E poi a qualcuno tocca di sostituire un genio del calcio come Michel Platini. Compito ingrato, da qualunque angolatura la si guardi questa storia, capitata una ventina di anni fa al trevigiano Marino Magrin. Interno di regia, classe 1959. Nato a Borso del Grappa, quasi seimila anime addossate ai piedi del Monte omonimo in Veneto. Terra fertile quella veneta, visto che ha dato i natali a molti calciatori di un certo livello. Lui, alle alte vette, ci è arrivato partendo da lontanissimo, piolo dopo piolo di una scala che dai gradini precari della Serie D con il Bassano, è passata via via a quelli più impegnativi, ma stabili delle categorie professionistiche.
Un’ascensione laica che lo ha portato dall’inferno delle bocciature dei primi provini perché troppo magro (omen nomen), al paradiso del pallone: la Serie A. Il massimo campionato. La Juventus, il top in fatto di storia e tradizione vincente. Purtroppo molta storia e tradizione e poche circostanze vincenti per il buon Marino nel suo biennio bianconero. Non solo l’eredità di un mostro sacro da portarsi dietro, anche negli spogliatoi. Ma anche la chiusura di fatto di un ciclo. Un tempista al contrario Marino Magrin che, nonostante il recente matrimonio con il rossonero del Milan, vivrà intensamente l’anticipo serale della dodicesima giornata tra Atalanta e Juventus. «Sono legato a entrambe le società. Nell’Atalanta mi sono formato, per poi arrivare alla Serie A dalla C1 da cui ero partito. La Juve è la Juve. Basta il nome. Ci sono stato due anni, per me una soddisfazione immensa».
– Quando c’è Atalanta-Juventus cosa fai? «La guardo, nella speranza di vedere del buon calcio. La Juve è forte, non solo fisicamente. Ha qualità, anche se io credo che la prolungata indisponibilità di Del Piero abbia penalizzato la squadra».
– Ciro Ferrara ti convince? «Gli faccio un grande in bocca al lupo, sincero. Sono contento per lui, i giovani è giusto che emergano. Quello che trovo discutibile è che, guardando più in generale, siano più o meno sempre gli stessi quelli che girano da una panchina all’altra a prescindere dai risultati. Chissà perché».
– Tra questi immagino non ci sia Antonio Conte? «Ci mancherebbe. L’anno scorso ha portato il Bari in A. È motivato, ha entusiasmo e credo possa far bene a Bergamo. Mi dispiace per Gregucci. Le prime due gare casalinghe dell’Atalanta sono state jellate e hanno pesato molto sul suo destino».
– Chi è l’uomo in più dell’Atalanta? «Cristiano Doni. È lui il cuore della squadra e a trentasei anni per giunta. E pensare che a me a trentatré mi hanno fatto smettere».
– Problemi fisici? «Macché! Stavo benissimo».
– Cosa è successo allora? «Banalmente, promesse non mantenute. Avevo chiuso con il Verona, in A nel 1992. Tornai a Bergamo, o meglio, avrei voluto tornare. Purtroppo la famiglia Bortolotti non c’era più e le parole spese a suo tempo se ne sono andate con il vento».
– Delusione quanta? «Parecchia. Non pensavo di smettere così. Me ne sono fatto una ragione ed ho iniziato a pensare al dopo, cercando di costruirmi un presente come allenatore. Ho fatto una buona esperienza con il Mantova in C2, sono stato anche nel vivaio dell’Atalanta e da questa estate mi hanno affidato i Giovanissimi Regionali del Milan».
– Il Milan? E cosa c’entra con il te il rossonero? «È incredibile, ma nei momenti importanti della mia vita calcistica, c’è sempre stato il Milan. A diciassette anni, quando giocavo con il Bassano, feci un provino a Milanello con Gustavo Giagnoni. La prima volta che ho giocato a San Siro, c’erano i rossoneri dall’altra parte. Oltretutto in quella occasione feci pure gol. A Terraneo quando era al Milan ho realizzato il gol su punizione più bello della mia carriera. Ma non è finita. Vigilia di Natale, campionato 1985-86. Si gioca a Bergamo, campo ghiacciato. Stranamente Sonetti mi tiene fuori. Ci sto male. A dieci minuti dalla fine, sull’1-0 per il Milan, mi mette dentro. Al 90’, su mia punizione, Simonini pareggia di testa. Finisce la partita, Sonetti mi abbraccia ed io gli dico: Mister, perché non mi ha fatto giocare? E lui: Era tutta una tattica, così entravi riposato!».
– Sa tanto di presa per i fondelli. «È proprio così. Ma questo era anche uno dei pregi di Nedo Sonetti, toscanaccio davvero. Insieme a Ottavio Bianchi lo considero uno dei maestri più importanti».
– Gli altri chi sono stati? «Prima di tutto mia madre. Una donna stupenda, che ha saputo mandare avanti un’intera famiglia da sola. Papà è morto giovane, io avevo appena sei anni. Vita dura, impari fin da bambino a sudarti la pagnotta. Ma quando la mangi è più saporita».
– La tua pagnotta comprendeva anche il pallone? «Vedevo solo quello. La scuola mi dava fastidio, mamma mia che intoppo. Nella mia testa c’era solo il pallone. Una passione viscerale, una droga. Detto tra noi, mi succede anche ora: lo tocco, lo carezzo, lo coccolo. Mia moglie mi prende per matto. Ma è così».
– Hai avuto ragione tu, comunque: con il pallone ti sei realizzato. «La voglia di giocare mi ha portato lontano, è vero. Forse più di quanto non sperassi, specie quando passavo le mie giornate in falegnameria. Dopo la terza media, per cinque anni ho fatto il falegname. Sul serio. La sera allenamenti. Pallone e segatura questo il programma. Con i ciocchettini di legno improvvisavo dribbling e doppio passo. Sul mio armadietto incollavo le figurine di Mazzola e Rivera».
– Erano loro i tuoi idoli? «Mi piacevano i calciatori tecnici, mi ci rivedevo. Ricordo quella volta del provino al Milan. Rivera era a due metri da me. Non mi sembrava vero. Oggi lo dico ai ragazzini che ho io. Voi dovete mirare alto. Vi dovete vedere a fianco di Pato».
– Non è pericoloso dire così? E per quelli che non ci arrivano? «Attenzione. Al Milan si lavora seriamente. Noi formiamo delle persone per un futuro che potrebbe essere anche fuori dal calcio. Bello sarebbe se tutti i ragazzi che ho adesso sfondassero. Comunque sia, puntare in alto significa non accontentarsi, andare alla ricerca del miglioramento, progredire. In una parola crescere. E questo è un valore, in campo e fuori. Mi dispiace che qualcuno non capisca che questo è il compito dei vivai: educare».
– Forse a te viene più facile perché hai fatto tutta la gavetta. «Può essere. Sono partito dalla Casonese, a diciassette anni ho debuttato in Serie D con il Bassano. Poi il Montebelluna, quindi il Mantova e poi l’Atalanta che mi ha preso in C1 e che anche grazie a me è arrivata in A. Una progressione, lenta ma costante. Con una caratteristica curiosa. Non ero mai la prima scelta. Nel senso che andavo sempre a rimorchio del compagno più richiesto sul mercato. Ho saputo sfruttare al meglio le situazioni. La soddisfazione più grande era quella di convincere l’allenatore e di dimostrare che ero in grado di farcela, nonostante qualcuno avesse nutrito dei dubbi su di me e mi avesse di fatto bocciato negli anni giovanili».
– Se vuoi, ho un contenitore per raccogliere i sassolini. (ride) «Accetto l’invito. Il granchio più grosso lo prese Gianbattista Pastorello ai tempi in cui era al Padova. Mi bocciò perché ero troppo magro: Tu sei bravo, ma troppo magrolino, mi disse. Ci rimasi male, anche se poi queste cose in me hanno sempre funzionato in maniera positiva, nel senso che mi spingevano a cercare una nuova occasione».
– E sei arrivato niente meno che alla Juventus! «Una conquista vera, meritata. Una soddisfazione enorme, grandissima. Pensa che qualche anno prima con l’Atalanta facemmo un’amichevole con la Juve. Ero emozionatissimo, di là fra i tanti campioni c’era anche Tardelli. Alla fine della partita mi avvicinai e gli dissi: Signor Tardelli, posso fare una foto con lei? E quando mi sarebbe ricapitata l’occasione? Non potevo immaginare che di lì a qualche anno sarebbe passato il treno bianconero».
– Dal quale, però, oltre a Tardelli, era sceso anche un certo Michel Platini. «Lo sapevo, lo sapevano tutti».
– Ti pesava il fardello lasciato dal francese? «Avrebbe pesato su chiunque. Anzi ha pesato su tutta la squadra. Nel calcio, come in altri settori, ci sono i campioni e i fuoriclasse. Campione lo puoi diventare, fuoriclasse ci nasci. Platini era uno di questi. Non ci sono possibilità di clonazione. Sono insostituibili».
– Tu sapevi che la Juve ti voleva per quello? «Io sapevo che mi volevamo anche altre squadre oltre alla Juve, tra cui l’Inter. In più so che Arrigo Sacchi aveva fatto dei piani su di me».
– Sacchi era al primo anno al Milan: come è che ti conosceva? «Ci eravamo incrociati l’anno prima della semifinale di Coppa Italia tra l’Atalanta e il Parma allenato da lui. Feci anche un gol di testa. Vincemmo e conquistammo la finale contro il Napoli di Maradona. Credo di essergli piaciuto, anche se, riguardo a questo episodio, è un’altra cosa che mi piace ricordare. Ricordo con piacere quella rete perché ci consentì di andare in finale. E siccome il Napoli aveva già vinto lo scudetto, qualunque fosse stato il risultato, l’Atalanta avrebbe comunque partecipato alla Coppa delle Coppe l’anno seguente».
– Come regalo d’addio alla tua squadra, niente male. «Credimi, mi è dispiaciuto molto lasciare l’Atalanta. Avevo ormai messo radici a Bergamo. Stavo bene, ma Bortolotti mi disse chiaramente che era il momento giusto per spiccare il volo. La Juve venne di conseguenza, anche per riparare allo sgarbo dell’anno precedente con Donadoni. Sia chiaro: per me andare alla Juventus era un sogno che si avverava».
– È vero che fu Marchesi a dare a te l’otto e il dieci di Platini a De Agostini? «È andata così, però vorrei aggiungere un paio di cose. La prima è che io ho sempre amato il numero otto. La mia posizione in campo è sempre stata sul centro-destra. Certo, Marchesi ha tenuto conto di altri fattori. Ma il tifoso non è stolto. E poi io l’ho sempre detto a tutti: non sono l’erede di Platini. Non potevo esserlo».
– Qualcuno, però, diceva che non eri nemmeno da Juve. «Queste sono state malignità. La verità è che nella mia prima stagione ho subito due infortuni nei momenti topici della stagione. Il primo già durante il ritiro. Giocai un’amichevole, feci gol su rigore. Non era scontato che toccasse a me. Segno che la squadra aveva fiducia nel sottoscritto. Qualche giorno dopo presi una botta e mi fermai. Non ti dico il giramento di scatole non potermi mettermi in mostra davanti all’Avvocato Agnelli nella classica partita a Villar Perosa!».
– Questo il primo stop. Il secondo invece? «A marzo 1988. Fin li posso dire di aver fatto un buon campionato. Qualche gol e diversi assist, purtroppo molti sciupati da Rush».
– Già c’era anche il gallese! «Una volta glielo dissi, anche se lui non parlava l’italiano e faceva fatica a capire. Gli dissi: Ian, devi segnare, non puoi sbagliare così. Se fai gol, fai fare bella figura anche a me. Messaggio non recepito».
– Torniamo al marzo 1988. «Successe tutto dopo la partita in casa con l’Inter, risolta da me con un rigore. Era già un po’ di tempo che i miei compagni volevano che io prendessi il dieci. Per me andava bene. Nei giorni precedenti la gara con l’Inter, un po’ per scommessa, un po’ per scaramanzia fu deciso che, se si fosse vinto con l’Inter e se io avessi giocato bene, per il resto del campionato avrei indossato la maglia di Platini. Non andò bene, perché il giovedì mi feci male e la bella avventura finì lì».
– L’anno dopo con Zoff hai giocato poco. «È vero, ma Zoff mi teneva molto in considerazione. Con lui ci fu anche un equivoco. Mi salvò Scirea quella volta. Giocavamo contro la Roma, a Torino. In tribuna c’erano dei miei amici di Bassano. Entro verso la fine della partita. Rigore decisivo per noi. Tocca a Cabrini, ma lui mi fa: vai tu. Paura alle stelle, tiro e segno. Poi mi metto a correre e vado a esultare sotto la tribuna, ignorando Zoff. Lui ci rimane male. Per fortuna chiarì tutto Gaetano, una persona per bene».
– Che ricordi hai conservato dei tuoi anni alla Juve? «Nel mio armadio ci sono ancora due maglie bianconere».
– Che numero hanno? «L’otto».
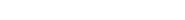





 Nessuna telefonata di Moggi con gli arbitri. Nessuna partita alterata. Chi indossa il nostro scudetto e lo mette in mostra con una copia, ha raggiunto il punto più basso di etica sportiva.
Nessuna telefonata di Moggi con gli arbitri. Nessuna partita alterata. Chi indossa il nostro scudetto e lo mette in mostra con una copia, ha raggiunto il punto più basso di etica sportiva.
 Secondo indiscrezioni raccolte da Tuttojuve.com, uno dei nomi accostati nuovamente ai bianconeri è quello di Danylo Sikan (23) dello Shakhtar Donetsk. L'attaccante, però, non stuzzica le idee della dirigenza bianconera, che sul fronte attaccanti potrebbe...
Secondo indiscrezioni raccolte da Tuttojuve.com, uno dei nomi accostati nuovamente ai bianconeri è quello di Danylo Sikan (23) dello Shakhtar Donetsk. L'attaccante, però, non stuzzica le idee della dirigenza bianconera, che sul fronte attaccanti potrebbe...
 Juve impegnata domenica sera a Monza. Dopo il successo in Coppa Italia, serve una svolta anche in campionato, per...
Juve impegnata domenica sera a Monza. Dopo il successo in Coppa Italia, serve una svolta anche in campionato, per...



 Andrea Bosco ha lavorato al “Guerin Sportivo“, alla “Gazzetta dello Sport“, al “Corriere d'Informazione”, ai Periodici Rizzoli, al “Giornale“, alla Rai e al Corriere della Sera.
Andrea Bosco ha lavorato al “Guerin Sportivo“, alla “Gazzetta dello Sport“, al “Corriere d'Informazione”, ai Periodici Rizzoli, al “Giornale“, alla Rai e al Corriere della Sera.
 Il Napoli avrebbe praticamente chiuso con il Lecce la trattativa per la cessione a titolo definitivo del cartellino di Luis Hasa, trequartista classe 2004 cresciuto nelle giovanili della Juventus. Come riportato da "Calciomercato.com", l'accordo tra le parti...
Il Napoli avrebbe praticamente chiuso con il Lecce la trattativa per la cessione a titolo definitivo del cartellino di Luis Hasa, trequartista classe 2004 cresciuto nelle giovanili della Juventus. Come riportato da "Calciomercato.com", l'accordo tra le parti...
 Il colosso dello streaming Netflix ha deciso di entrare in maniera importante nel mondo del calcio. Come annunciato in un comunicato infatti è stato raggiunto uno storico accordo con la FIFA per i diritti in esclusiva per gli Stati Uniti d’America per le...
Il colosso dello streaming Netflix ha deciso di entrare in maniera importante nel mondo del calcio. Come annunciato in un comunicato infatti è stato raggiunto uno storico accordo con la FIFA per i diritti in esclusiva per gli Stati Uniti d’America per le...
 La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, informa i tifosi bianconeri su dove vedere il match del campionato Primavera che i bianconeri giocheranno domani, a partire dalle 13:00, contro l'Atalanta a Zingonia:
U20 | ATALANTA-JUVENTUS, DOVE VEDERLA
"La...
La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, informa i tifosi bianconeri su dove vedere il match del campionato Primavera che i bianconeri giocheranno domani, a partire dalle 13:00, contro l'Atalanta a Zingonia:
U20 | ATALANTA-JUVENTUS, DOVE VEDERLA
"La...
 17:35 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus ha terminato l'allenamento pomeridiano in vista della gara contro il Monza. A breve i bianconeri partiranno alla volta della Lombardia.
15:22 - ALLENAMENTO IN CORSO - La Juventus è in campo e si sta...
17:35 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus ha terminato l'allenamento pomeridiano in vista della gara contro il Monza. A breve i bianconeri partiranno alla volta della Lombardia.
15:22 - ALLENAMENTO IN CORSO - La Juventus è in campo e si sta...
 La partita con il City è cambiata con due episodi, il primo Di Gregorio che salva su Haaland nel primo tempo e nel secondo la cavalcata di Federico Gatti che rompe gli schemi e fa ripartire la Juve innescando poi l'azione che porta al gol.
ROMPERE GLI...
La partita con il City è cambiata con due episodi, il primo Di Gregorio che salva su Haaland nel primo tempo e nel secondo la cavalcata di Federico Gatti che rompe gli schemi e fa ripartire la Juve innescando poi l'azione che porta al gol.
ROMPERE GLI...