Gli eroi in bianconero: Marco TARDELLI

Quando l’avevi davanti – racconta il sommo Caminiti – sembrava un’ipotesi di giocatore con qualcosa di meno. Te lo potevi immaginare a suo agio, tra gli sparati bianchi dei tavoli in quell’albergo di Pisa, o pensarlo commesso in un negozio di scarpe o postino addetto ai servizi celeri, con quel viso smunto infiammato dagli occhi che sembravano camminargli addosso, mai fermi, come lui. Che era così gracile e come penato, Marco Tardelli, cioè uno dei sei fuoriclasse che il francese blasé Platini si sarebbe trovato al fianco in una Juventus destinata a divenire leggendaria.
Quelli erano giorni di calcio torinese e juventino estremamente razionale, fatte le debite eccezioni, che erano appena due, poi sarebbero state quasi tre (con l’eccentrico Marocchino), e cioè Causio detto Brazil e lui. Ma nessuno come Tardelli, che il soprannome se l’era scritto addosso, come quando da un calamaio schizza una goccia o più gocce e subito il quaderno è una macchia sola, e il bambinetto piange. Schizzo Tardelli faceva piangere gli avversari, anche i portieri, e dire che io l’avevo scoperto da terzino di fascia fare i suoi incredibili gol di rapina, a Verona, quel pomeriggio in cui Saverio Garonzi era tornato a casa, e nel suo viso disfatto tra gli occhi pieni di quell’esperienza paurosa, si passava e ripassava una mano rugosa, illudendosi che il suo Verona lo avrebbe consolato, contro quel Como, regalandogli una bella vittoria.
Invece, sul verde prato del Bentegodi, in un pomeriggio che aveva tutte le svenevolezze dell’autunno, il Como aveva vinto, soprattutto per merito di Tardelli e l’osservatore della Juventus che era Cestmír Vycpálek, ne era rimasto incantato.
Quell’ipotesi di giocatore, guardato nel fisico, si trasformava in campo in una freccia di giocatore, dai piedi buoni, dalle intuizioni repentine anche nei movimenti senza palla; si capiva che nel ruolo di difensore esterno assolveva a una parte di un copione abbastanza vario. Quando avanzava, cioè schizzava da parte a parte, l’avversario costretto a rincorrerlo senza pigliarlo mai, si trovava la lingua in gola.
La Juventus aveva pescato il tipo giusto per fare quagliare le intese smarrite un anno prima; il campionato di grazia 1976-77 le avrebbe restituito ogni avere con gli interessi. La più razionale Juventus dell’era Boniperti inseriva nel contesto il più trascedentale scattista e incontrista d’Italia, equilibrando il filtro di centrocampo affidato all’alluce d’acciaio di Benetti e all’indomito sprint tattico di Furino, con il risultato di varianti inedite per l’attacco prestigiatore di Bettega e martellatore di Boninsegna.
Vincendo scudetti e Coppe, Marco Tardelli non poteva ancora essere soddisfatto. Una perenne inquietudine gli ardeva negli occhi, sposo e padre senza avere molta serenità, cercava in campo ogni più ardua gioia, la scovava addirittura con i suoi guizzi felini, attraverso gol pazzeschi e irresistibili. Divenne così alla base della Nazionalbearzottiana, con pipa (le pipe egregie di quegli anni erano due, la più illustre apparteneva al Vecchio Pertini, Presidente con la passione dei Media), vi avrebbe giocato 81 volte, fulcro di quel contropiede manovrato schizzante (appunto Tardelli) esordendovi come terzino destro il 7 aprile 1976 nell’amichevole torinese vinta per 3 a 1 sul Portogallo.
Bearzot e pipa, a quel punto, sedevano ancora in compagnia di Nonno Bernardini, ultime lezioni al furlan che sarebbe riuscito con la sua facondia e versatilità psicologica a fare della Nazionale un pugno di uomini con un ideale. Come definire altrimenti la squadra che tra giugno e luglio dell’82 andava a farci rivivere le imprese dei padri che con prosa emozionante Emilio De Martino ha raccontato in un libro degno di essere conosciuto dai ragazzi: cioè Carovana azzurra? Quella domenica di luglio dell’82 fu di sofferenza, prima del tripudio, nello stadio che era di un pallore svenato dalle luci (anche quella chiarissima del cielo, annottò tardissimo), Tardelli segnò il gol più bello, famoso e importante della sua carriera, schizzando in caduta libera per scaricare il sinistro sul pallone del secondo gol, radente, irridente, per Schumacher. E subito la corsa liberatoria per il prato, a pugni stretti, gridando la gioia, come si può gridare con tutto il fiato del corpo e dell’anima, quasi a voler chiamare a testimoni presenti e assenti dell’impresa compiuta, per se stesso, per tutti, anche per la pipa di papà Bearzot e, perché no?, di nonno Pertini.
Quelli erano giorni: un’ipotesi di giocatore, con qualcosa di meno, campione del mondo. L’irripetibile, insostituibile Marco Tardelli.
MASSIMO BURZIO, DA “HURRÀ JUVENTUS” DEL MARZO 1988
Nel calcio italiano e mondiale degli anni Settanta e Ottanta ci sono stati molti grandi giocatori, ma pochissimi campionissimi. Uno di questi ultimi è stato Marco Tardelli, forse il miglior centrocampista della sua generazione. Difficile spiegare in poche righe cos’è stato per la Juventus e per la nazionale azzurra Marco Tardelli. Difficile perché i tifosi juventini ed i calciofili hanno ancora, vivissime, negli occhi (e qualcuno nel cuore) le impareggiabili giocate di quel moto perpetuo che è stato Tardellino. Ed è stata una vera emozione quella di vedere, nei primi giorni di quest’anno, un allenamento della Juve a cui hanno partecipato Tardelli e Michel Platini. Due colonne di un passato neppure tanto remoto che avevano chiesto ed ottenuto di mantenere il ritmo partita del campionato svizzero (Tardelli), ed un poco di forma fisica (Michel Platini). È stato come tornare indietro ad un’epoca che certamente non ha eguali.
Schizzo è nato a Capanne di Careggine, in provincia di Lucca, il 24 settembre del 1954. I primi calci al pallone lungo i prati attorno a casa, qualche torneo minore ed ecco che i dirigenti del Pisa notano il ragazzino smilzo che vola per tutto il campo. Detto e fatto e c’è il primo cartellino per i nerazzurri pisani. Lo stipendio è scarso e così Marco studia, gioca a calcio e lavora. E sempre uno scricciolo e, quando passa al Como, c’è qualche dirigente che pensa d’aver fatto un affare lasciando ai comaschi quel terzino così smilzo che difficilmente avrà il fisico per fare strada. La pensano così anche i dirigenti della Fiorentina a cui Marco è stato invano proposto e negative sono anche le relazioni fatte dagli osservatori nerazzurri all’allora presidente dell’Inter, Ivanoe Fraizzoli. Ed invece Tardelli nel Como trova spazio e possibilità per far vedere che non è necessario essere dei culturisti per giocare a calcio: basta avere un fisico vero ed essere dei campioni.
L’Inter fa marcia indietro e torna alla carica con i dirigenti lariani, siamo nel 1975, arrivando ad offrire per il cartellino di Marco quasi un miliardo. Al Como rispondono con cortesia ma anche con decisione. «Ci spiace», affermano i dirigenti della squadra, «ma Tardelli è già bianconero».
Così Fraizzoli torna sconfitto a Milano con una sola magra consolazione: quella d’avere una foto accanto a Tardelli. Ma cos’è accaduto? Nulla o quasi, soltanto che la Juventus si è offerta di pagare in contanti laddove altri facevano solo promesse e dilazioni e non davano sufficienti garanzie di solvibilità. E stato, insomma, un affare tra business man e, soprattutto, è stato un grande colpo per la Juventus.
Alla Juve arriva un Tardelli ventenne che si è fatto le ossa vincendo una stagione di B con, appunto, il Como e che Carlo Parola impiega come terzino con notevole giudizio e saggezza. Marco non viene infatti gettato nella mischia, inizia dalla panchina crescendo fisicamente e psicologicamente col passare del tempo. Ma è un anno buio per la Juve che regala uno scudetto quasi vinto al Torino. Così a fine stagione se ne va Parola ed arriva Giovanni Trapattoni: un allenatore giovane pronto a far giocare una squadra di giovani. Per Tardelli, che sul finire della stagione precedente, ha già conosciuto la gioia della maglia azzurra, è la definitiva consacrazione in un ruolo, tra l’altro, diverso da quello precedente. Il “Trap”, infatti, imposta Marco da centrocampista avendone riconosciute le grandi qualità di dinamicità, visione di gioco e forza propulsiva. È un’annata eccezionale, quella. La Juve vince la Coppa Uefa e fa suo lo scudetto con il punteggio record di tutti i tempi, 51 punti. È una Juve tutta italiana, una Juve incredibile, forse la migliore del calcio di Trapattoni.
Quella Juve ha a centrocampo gente come Furino, Benetti e Tardelli, in difesa ci sono Scirea, Morini, Cuccureddu, Gentile ed a volte Antonio Cabrini, mentre dietro a tutti la sicurezza di Dino Zoff. Davanti giocano Causio, Boninsegna e Bettega. Insomma una Juve extra, che ha in Tardelli un leader giovane e grintoso. Anche in azzurro Marco diventa centrocampista presentandosi alla platea mondiale con classe ed una voglia di giocar bene e vincere, che lo fa notare e primeggiare tra tutti i giocatori di quel periodo. Ancora scudetti, campionati, partite internazionali, un mondiale in Argentina ed una cavalcata vincente in Spagna, come non ricordare quel suo goal nella finale con la Germania e l’urlo di gioia di Schizzo che era poi l’urlo di tutta Italia; insomma una carriera davvero unica e sorprendente.
Ed è nel 1985 che Tardelli lascia la Juventus. Il distacco sembra un poco brusco, ma è tipico di tutti i grandi amori che proprio perché tali non possono finire in modo banale. Marco se ne va all’Inter (dove peraltro non avrà grande fortuna) con un’aria a metà tra il soddisfatto e l’insoddisfatto. La cosa è tipica (basta consultare i manuali di psicologia) di chi è alla fine d’una grande avventura personale ed è diviso tra il rimpianto per il passato e la voglia di futuro.
Oggi Tardelli gioca in Svizzera, nel San Gallo. È rimasto a lungo senza contratto perché all’Inter ha rifiutato un’offerta economica magari valida ma che lo voleva inizialmente in panchina. E lui, da guerriero qual è, non voleva partire già con una penalizzazione.
La storia bianconera di Tardelli è quella che sin qui ho cercato di scrivere. Inutile fare commenti tecnici o cercare ancora di dire come giocava Tardelli e chi era Tardelli per la Juve e nella Juve: basta dire che era Tardelli. E basta così. Senza altre parole per un giocatore unico in una Juve unica, magari eguagliabile nei risultati ma non nelle caratteristiche umane e tecniche del nucleo che ne fu forza e propulsione vincente.
NICOLA CALZARETTA, DAL “GS” DELL’OTTOBRE 2012
Sei mesi a Londra, tre a Dublino e il resto in Italia. Dal 2008 Marco Tardelli, vice di Giovanni Trapattoni Commissario Tecnico dell’Eire, vive così. Oddio, non molto diversamente da come ha sempre fatto, correndo da una parte dall’altra del campo, nei suoi quindici anni da calciatore. Londra è la sua base. La Federazione irlandese gli ha messo a disposizione un appartamento. Da lì si sposta per andare a vedere i suoi nazionali che giocano tutti o quasi in Premier League. Il Trap è rimasto a Milano, il lavoro sul campo lo fa lui. La fiducia è totale, come la sintonia. Dublino è il quartier generale della Nazionale. In Italia torna quando può. E Cernobbio il suo buen retro. La vista sul lago di Como è mozzafiato. Ci sistemiamo sul divano bianco nel salotto, con vista a favore dello stupendo panorama. Clima disteso c’è spazio anche per una scherzosa telefonata all’amico Collovati. Arriva Laura, la sua compagna. Sorriso gentile ci porta il caffè e una macedonia di pesche. Bene, si può partire con l’intervista amarcord. Le lancette vengono spostate indietro di trent’anni.
Estate 1982, nasce la super Juve dei sei Campioni del Mondo, più Bettega, Boniek e Platini: «E si parte subito in salita».
Ti riferisci alle polemiche sui reingaggi? «Provammo a sfidare Boniperti. Ma perdemmo il duello».
Ci puoi dare qualche dettaglio in più? «Semplice: eravamo Campioni del Mondo e ci sembrò giusto chiedere un adeguamento del contratto. A questo mettici che erano stati presi i due stranieri ai quali, sicuramente, era stato garantito un ingaggio superiore al nostro. Andammo dal presidente e provammo a trattare. Non che alla Juve si prendesse poco. Con i premi alla fine della stagione arrivavano dei bei soldi».
E Boniperti? «La prese malissimo, non era abituato a quel tipo di situazione. In particolare si arrabbiò con me, Gentile e Paolo Rossi. Non giocammo la prima amichevole stagionale e lui ci mise contro i tifosi. Questo non mi piacque per niente. E, ovviamente, ottenemmo molto, molto meno di quello che speravamo».
Meglio parlare del campo, allora. Nuova Juve spettacolare: ci sono Boniek e Platini. «Ma non c’era più Brady, un ragazzo stupendo, vittima di un regolamento che all’epoca non prevedeva più di due stranieri per squadra. Eravamo tutti molto legati a Liam. La sua partenza ci fece male, qualcuno pianse. In due anni con lui abbiamo vinto due campionati. Senza dimenticare il rigore di Catanzaro che ci consegnò il ventesimo scudetto. Lo tirò nonostante avesse già saputo che non sarebbe stato riconfermato».
C’è una foto che ti ritrae di spalle quando Brady è sul dischetto: «Ero in tensione. Ti immagini, in un paese come il nostro, cosa sarebbe successo se l’avesse sbagliato? Come minino avrebbero detto che l’aveva fatto apposta. Magico Liam, un grande professionista e un amico vero, che una volta mi fece quasi ubriacare».
Davvero? «Brady era arrivato da poco alla Juve. Io ero tra quelli che all’inizio lo aiutò un po’ nella nuova realtà. Una sera, dopo una partita di Coppa Italia, lo accompagnai in albergo. Mi invitò a bere con lui una birra. Lui beveva tranquillamente, io alla prima ero già steso per terra. Ma la cosa più buffa la combinò qualche tempo dopo con la macchina».
Che fece? «Abituato alla guida a destra, imbroccò le rotaie del tram. Fece un gran casino, alla fine chiamò Furino che era anche il suo assicuratore per farsi aiutare. Ripeto: un ragazzo speciale che fu costretto a lasciare la squadra per far posto a un altro».
Che si chiamava Michel Platini, però: «All’inizio vissi male questa cosa, soprattutto perché non conoscevo bene Michel. Da avversario lo avevo marcato un paio di volte e mi aveva messo in difficoltà, giocando a tutto campo. Sembrava grassottello, aveva i piedi alle “dieci e dieci”, eppure ti faceva impazzire. Come persona credevo fosse un tipo con la puzza sotto il naso, che ci avrebbe fatto pesare la sua grandeur».
Allora è vero che all’inizio Furino non gli passava il pallone! «Se è per questo Furino non lo passava mai a nessuno. (ride) È stata una battuta di Platini all’Avvocato Agnelli».
Come si è evoluto, allora, il tuo rapporto con Michel? «Intanto sul campo. Platini non ha mai saltato un allenamento. Mai. Era un esempio. Provava le punizioni milioni di volte. Un professionista serio, dotato di grande ironia e, soprattutto, di notevole intelligenza. In partita, poi, vedevi che era di un’altra categoria. Non ho mai visto nessuno giocare con la semplicità di Michel. Inventava quando c’era da inventare, anche se non era Maradona. Ma la cosa fantastica è che rendeva tutto semplice. Questa era la sua vera grandezza».
Siete diventati amici? «Strada facendo sì. Ho potuto apprezzare che non aveva nessun complesso di superiorità. Anche oggi che è il presidente dell’Uefa, se lo chiami, lui c’è».
Di Platini abbiamo detto. E di Boniek? «Boniek? Un polacco napoletano arrivato a Torino. Simpatico, furbo, imparò subito la lingua alla perfezione. Quando finiva un’azione, lui andava dalla parte opposta dove non c’era nessuno, per farsi trovare libero. E con i lanci al millimetro di Platini era una goduria».
Platini che lancia Boniek: lo schema per eccellenza della Juve 1982/83: «Non il solo. C’erano anche altre soluzioni: era una squadra molto offensiva con i vari Rossi, Boniek, Platini, Bettega, Cabrini, che faceva l’ala, e il sottoscritto che entrava. Scirea, poi, ci dava sempre l’uomo in più a centrocampo. Senza dimenticare Marocchino, intelligentissimo e molto dotato. In allenamento, però, una vera sciagura».
Ci hai mai litigato? «E come fai con persone così? È impossibile, come con Tacconi. Lui faceva delle dichiarazioni esplosive e noi nello spogliatoio gli dicevamo: “Ma ti rendi conto di quello che hai detto?”. “E perché? Cosa ho detto?” Con lui mi sono arrabbiato solo durante una partita».
Quando è successo? «Nel finale del derby del 18 novembre 1984, goal preso al 90’ da Serena, colpo di testa sul primo palo. Lui dette la colpa a me, io gli risposi per le rime. Ci fu polemica. La domenica dopo giocò Bodini e i giornali scrissero che ero stato io ad aver fatto fuori Tacconi. Al là di questo episodio, Tacconi e Marocchino sono stati due sani mattacchioni. Marocchino credo sia stato l’unico giocatore che la Juventus sia andata a prendere con il pullman sotto casa prima di una partita».
Perché in campo era utilissimo, giusto? «Tecnicamente era bravissimo. Quando c’era bisogno di tenere palla e di rifiatare, la davamo a lui. Era difficile togliergliela. Torno a dire: quella squadra era di grandissima qualità e votata all’attacco. Mi fanno ridere ancora oggi le critiche al difensivismo del Trap».
Paolo Rossi però usciva spesso prima del novantesimo: «Pablito faceva un lavoro enorme, muovendosi molto in orizzontale per favorire gli inserimenti da dietro. Era una giocata molto amata dal Trap e che provavamo spesso in allenamento».
Facevate sedute tattiche specifiche? «Parliamo di trent’anni fa. Si giocava tutti in maniera più semplice. Trapattoni, però, stava molto sul campo. Si provavano i corner, le punizioni e alcune soluzioni d’attacco».
All’inizio della stagione quella Juve, a detta di tutti, avrebbe vinto qualunque cosa: «E alla fine, invece, vincemmo solo la Coppa Italia».
Perché? «In campionato scontammo le fatiche di Spagna. Era già successo quattro anni prima, dopo i Mondiali d’Argentina. Eravamo stanchi. Platini aveva la pubalgia. Un guaio pesante che lo condizionò per tante domeniche. E poi c’era la Roma che andava forte quell’anno».
Ma che voi batteste due volte: «Quelle con la Roma erano partite tirate. C’era tantissima rivalità, più fuori che in campo, però. Il vero duello era tra Boniperti e Viola, che si scambiavano regali goliardici e battute velenose».
In campionato così così, ma in Coppa dei Campioni la Juve vola. Perché? «Volevamo tutti la Coppa, da Boniperti in giù. Non che ci fossimo stancati di vincere gli scudetti, anzi. Sappi che la cosa bella dello sport non è vincere, ma rivincere. L’Europa, le partite in notturna, certi stadi ti danno qualcosa in più. Diciamo che eravamo più motivati».
Il percorso d’avvicinamento alla finale fu senza sconfitte: «E incontrammo avversari fortissimi. Lo Standard Liegi era un osso duro. Andammo a vincere a Birmingham contro l’Aston Villa detentore della Coppa: 1-0 per noi, pareggio loro e goal vittoria di Boniek nel finale. Recentemente ho incontrato Cowans (autore dell’1-1, ndr). Gli ho chiesto se ricordava ancora quella gara: mi ha detto che è impossibile dimenticarla».
Pensi che quella sia stata la partita della svolta? «L’arrivo di Boniek e Platini ha agevolato e accelerato un cambio di mentalità che già era in atto. Prima si giocava in modo diverso a seconda se si fosse in casa o fuori. Una condizione mentale che ci ha spesso frenati. A Birmingham stavamo pareggiando 1-1, era la partita d’andata. Ci si poteva anche accontentare. E invece abbiamo puntato alla vittoria. Un approccio diverso, più moderno».
A proposito di Aston Villa. Nel ritorno a Torino c’è un tuo gran goal di testa in tuffo: «Era una mia specialità: inserimento da dietro, taglio sul primo palo, stacco e goal. Lì ci fu anche un blocco di Gentile degno di un giocatore di basket. Poi ci sbarazzammo dei vecchi compagni di Boniek, il Widzew Lódz, e conquistammo la finale, dieci anni dopo Belgrado».
Ed eccoci alla data fatidica: 25 maggio 1983, Atene. «E chi se la scorda! Una legnata frutto di tanti errori. Arrivammo allo stadio troppo tempo prima, per paura del traffico. Eravamo tranquilli ma svuotati. Ci davano tutti per vincenti, la partita era vista come una formalità. Non fummo in grado di interpretare alcuni segni premonitori, come quelli che si erano visti nell’ultima partita infrasettimanale. Un disastro».
Rimaneva il campo. Lì cosa è successo? «E successo che al loro goal siamo crollati. Quella sera ciascuno di noi ha fatto qualcosa in meno. L’Amburgo fu sottovalutato da tutti, anche da Boniperti. Ma loro in panchina avevano Happel, un grande allenatore».
Il Trap poteva fare qualcosa in più? «In quelle occasioni per un allenatore c’è solo una cosa da fare: il segno della croce».
Rimaneva la Coppa Italia per salvare la stagione: «Ci buttammo sull’ultimo obiettivo. A parte Zoff, che fu sostituito da Bodini, per il resto eravamo gli stessi di Atene. Volevamo vincere. Ricordo la determinazione durante le finali contro il Verona. In particolare Cabrini dette un paio di stecche a Farina, nostro compagno fino all’anno prima. Con quest’ultimo a chiedere ad Antonio: “Ma non eravamo amici?”».
A proposito di duelli, tu ne sai qualcosa avendo marcato grandi fuoriclasse: «Specie nei primi anni di carriera, l’avversario più forte toccava a me. Ho marcato Platini, Maradona, Channon, Keegan. Colpi dati, qualcuno preso, una stupida gomitata a Keegan, ma anche tanti anticipi, la mia vera forza».
Ti sei dimenticato un’ammonizione record dopo tre secondi contro Rivera: «Io feci un’entrata decisa, lui accentuò un po’. È vero che erano passati pochissimi secondi dal calcio d’inizio. Ma quello era uno schema. Qualche domenica prima, contro il Verona (6-2 per la Juve, ndr), su sei volte io rubai palla in quattro occasioni».
Qualcuno ricorda anche un rosso nella partita tra Argentina e Resto del Mondo, un’amichevole: «Non esistono amichevoli. Esistono partite. Di là c’era Maradona che mi fece dannare. Anche se l’unico giocatore che mi ha messo veramente sempre in bambola si chiama Nicola Ripa, ha giocato anche nel Foggia in A. Con lui non l’ho mai spuntata, fin dai primi campionati con il Pisa in Serie C».
Quando non arrivavi a pesare nemmeno sessanta chili? «Altri tempi (ride). Comunque è vero, ero magrissimo. Il motivo di molte bocciature ai provini. E successo con Pesaola per il Bologna, Maroso per il Varese e Radice per la Fiorentina. Al Pisa in pratica mi regalarono, visto che per il cartellino pagarono 70.000 lire».
Ma tu da piccolo volevi fare il calciatore? «A me piaceva il pallone. Il sogno si fermava a giocare nel Pisa, squadra della mia città. Mio padre si era trasferito lì dalla Garfagnana per consentire alla famiglia di vivere meglio. Eravamo quattro fratelli, io ero l’ultimo».
Com’è stata la tua infanzia? «Bellissima. Buona non lo so, perché non avevo una lira. A me toccavano tutti i recuperi dei fratelli più grandi. Non c‘erano motorini, la bicicletta era il collage di tanti pezzi trovati qua e là. Si giocava per strada, si stava all’aria aperta. D’estate ho sempre lavorato. Facevo il cameriere. Una volta mi trovai a servire Zoff che era al Ciocco in ritiro con il Napoli. Non ti dico l’emozione. Arrivato alla Juve, glielo dissi e lui mi ha preso in giro per una settimana».
Che rapporto avevi con Zoff? «Dino è una persona stupenda. Ti racconto questo: allenamento mattutino, io faccio qualche entrataccia, sono nervoso. Nel pomeriggio squilla il telefono di casa. E Dino che mi dice di aver chiamato per sapere come sto, dato che la mattina mi aveva visto piuttosto teso. Queste sono le cose che rimangono».
Da bambino per chi stravedevi? «Agli inizi giocavo come attaccante e avevo un debole per Gigi Riva. Pensa che per tre mesi calciai solo di sinistro per migliorare il piede e per assomigliare sempre di più a lui».
Avevi anche una squadra del cuore? «Era l’Inter, ma per esclusione. I mie tre fratelli tenevano per la Juve, il Milan e la Fiorentina».
Hai detto Inter e il pensiero vola all’estate 1975. Ci racconti come la Juve ti soffiò ai nerazzurri? «Venivo dalla promozione in A con il Como. La mia valutazione era di un miliardo circa, tantissimi soldi se si pensa che erano per un terzino di ventuno anni. L’Inter offre 750 milioni più Guida, giovane difensore centrale. Sembra tutto fatto, tanto che faccio anche delle foto con il presidente Fraizzoli».
E invece? «E invece la Juve dette 950 milioni cash al Como che mi chiamò e mi disse di andare a Torino».
Preoccupato della valutazione? «Un po’ sì. Per fortuna arrivai in una società seria, con persone eccezionali e compagni che mi aiutarono molto. Ricordo Altafini che si divertiva a prendere in giro i giornalisti: arrivava all’intervista con la gamba fasciata facendo finta di essere infortunato, per giustificare l’esclusione la domenica successiva. Poi Spinosi che mi ospitò per un po’ in casa sua. Tra l’altro, fu lui a chiamarmi Schizzo, perché ero magro e veloce. Anche se il ricordo più buffo riguarda Gaetano Scirea».
A te il microfono: «Alla fine di quella prima stagione, presi in affitto una casa a Tirrenia per ospitare al mare tutta la mia famiglia. Un giorno invitai anche Gaetano. Lui arriva e chiede informazioni su dove fosse la casa e chi ti becca? Il postino che è uno dei miei fratelli. E vabbè. Arriva, mangiamo e la sera sai che si fa? Si gioca a nascondino tra di noi. Ti rendi conto?»
Certo Scirea era di un altro pianeta: «Aveva una corazza. Non faceva trapelare nulla. Era amato e rispettato. Dovunque si andasse a giocare, per lui c’erano applausi. Per la Juve ha dato tutto, almeno un paio di volte ha giocato facendosi ricucire delle ferite ai piedi durante l’intervallo. Da noi compagni è stato sempre amato. Un po’ meno dal resto del mondo».
Torniamo al tuo primo anno in bianconero: credevi di sfondare subito? «Arrivai come terzino. In difesa quell’anno c’erano Gentile, Cuccureddu, Morini, Scirea e Spinosi. M’impegnai al massimo, misi su anche qualche chilo. E Parola mi dette fiducia. Una stagione da incorniciare, con l’unica grandissima amarezza dello scudetto perso all’ultima giornata contro il Torino. Eravamo cotti».
La svolta, comunque, era vicina. Di lì a poco Boniperti ingaggia Trapattoni: «Con il Trap ci fu un salto in avanti e per me un primo anno bellissimo, ma anche carico di paure».
A cosa ti riferisci? «Al cambio di ruolo. Sia chiaro: a me piaceva di più stare a centrocampo, lo avevo già fatto a Como. Il problema è che in Nazionale continuavo a giocare terzino. Avevo il timore di perdere il posto in Azzurro. Invece è andata bene, la doppia vita è durata poco, poi anche in Nazionale sono stato schierato a centrocampo».
Qual è il ricordo più bello di quella fantastica annata 1976/77? «L’entusiasmante notte di Bilbao. Un’emozione unica. Una sofferenza indicibile. All’andata avevamo giocato meglio. Feci goal io di testa, con carambola sulla spalla, ne venne fuori un pallonetto imparabile per Iribar che era il sosia di Zoff, incredibile. Al ritorno andammo subito in vantaggio, poi ci misero sotto. Lo stadio era una bolgia. Era una finale tra due squadre autarchiche: loro tutti baschi, noi tutti italiani».
Orgoglioso quanto? «Molto. Anche perché la nostra era veramente una squadra. C’era la voglia di stare insieme e questo si vedeva soprattutto durante la settimana, negli allenamenti. C’era uno spirito nazionalistico che ci dava qualcosa in più. Ci furono anche gesti particolari, come quello di Boninsegna che quella sera fece anche lo stopper. Quando alzammo la Coppa Uefa, sentii di aver fatto qualcosa di veramente bello e importante».
Paralleli con Spagna 1982? «Il Mondiale è stato un evento unico. Io non stavo bene. Fui attaccato pesantemente anche da Brera. Mi chiamava Gazzellino, ma poi mi bastonava duramente. Devo tutto a Bearzot».
Ne vogliamo parlare del Commissario Tecnico? «Un uomo onesto, di grandi valori. Una persona seria, di ampia cultura. Severo, apparentemente burbero. Sentiva la responsabilità del gruppo, voleva sapere tutto di noi, che si faceva, dove si andava. Esigeva lealtà e rispetto. Chi mancava, non veniva più richiamato. Successe quella volta in America con Mancini. La sera uscì con me e Gentile, ma non avrebbe dovuto. Il giorno dopo Bearzot non gliela fece passare. E addio Azzurro».
Cosa c’era di particolare tra te e Bearzot? «Direi cosa c’era di particolare tra il gruppo e Bearzot. Lui guardava alle persone. Del campionato gli interessava il giusto. Un altro allenatore non mi avrebbe portato in Spagna. Lui sì. Quando durante i primi allenamenti mi vide strafare, mi rimproverò. Non sai quanto servono questi gesti. Poi difendeva sempre il gruppo, più di una volta ha cacciato dagli spogliatoi dei dirigenti che si impicciavano di cose tecniche».
È stato lui a darti il soprannome Coyote? «Sì. Non dormivo di notte, mai, ma non per la tensione. Non ho sonno. Spesso chiudevo la lunga nottata a parlare con lui. Ma in Spagna non ero solo: c’erano anche Bruno Conti, Oriali e Selvaggi».
In finale hai segnato di sinistro, come il tuo idolo Gigi Riva: «Anche all’Argentina ho fatto goal di sinistro, dopo un grande contropiede. Con la Germania, invece, è stato il tiro della disperazione perché avevo sbagliato lo stop e la palla mi stava scivolando via».
E poi, l’urlo: «Felicità pura. Gioia. Punto. Lo avevo sempre fatto, anche in Nazionale contro l’Inghilterra, nel 1980. Era il mio modo di esultare. Una volta Boniperti mi rimproverò. Successe al mio primo anno alla Juve, dopo un goal al Verona. Andai a festeggiare sotto la tribuna. In campo arrivò di tutto».
Marco, siamo alle battute finali. Manca l’Heysel: «Una pagina tristissima. Io e Cabrini a un certo punto uscimmo tra i tifosi per tranquillizzarli. Sapevamo pochissimo. C’era arrivata voce di un morto. Vedemmo un babbo stressato con il figlio in braccio che voleva andare via. Quel giorno sono stati commessi errori da parte di tutti. Della polizia, dell’organizzazione sicuramente. È stato un errore giocare. È stato un errore esultare».
Quella dell’Heysel è la tua ultima partita con la Juve: «La decisione di andare via era stata già presa. Non volevo più giocare terzino com’era successo durante l’ultima stagione. Avevo ricevuto due offerte dalla Roma e dall’Inter. Scelsi quest’ultima. Lasciare la Juve mi è costato fatica. Venne pure Edoardo Agnelli a casa mia, ma ormai i giochi erano fatti. Era giusto cambiare».
Un’ultimissima cosa: perché sopra i calzettoni mettevi il cerotto? «Per nascondere una medaglietta con l’immagine della Madonna».
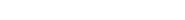





 Giuntoli esce allo scoperto. La JUVENTUS punta ai primi quattro posti, il progetto è nuovo e ci vuole tempo. Parole che lasciano perplessi i tifosi. Era necessario buttare giù il muro per rifarlo da capo?
Giuntoli esce allo scoperto. La JUVENTUS punta ai primi quattro posti, il progetto è nuovo e ci vuole tempo. Parole che lasciano perplessi i tifosi. Era necessario buttare giù il muro per rifarlo da capo?
 Nelle ultime settimane, come anticipato la scorsa domenica, la Juventus ha allacciato i contatti per Marcos Senesi (27). La società bianconera, come ben sappiamo, è alla ricerca di un difensore e Senesi è un nome presente, insieme ad altri,...
Nelle ultime settimane, come anticipato la scorsa domenica, la Juventus ha allacciato i contatti per Marcos Senesi (27). La società bianconera, come ben sappiamo, è alla ricerca di un difensore e Senesi è un nome presente, insieme ad altri,...
 Dibattito aperto dopo l'ottavo pareggio della Juve in campionato, maturato nella trasferta di Lecce. I problemi...
Dibattito aperto dopo l'ottavo pareggio della Juve in campionato, maturato nella trasferta di Lecce. I problemi...



 Andrea Bosco ha lavorato al “Guerin Sportivo“, alla “Gazzetta dello Sport“, al “Corriere d'Informazione”, ai Periodici Rizzoli, al “Giornale“, alla Rai e al Corriere della Sera.
Andrea Bosco ha lavorato al “Guerin Sportivo“, alla “Gazzetta dello Sport“, al “Corriere d'Informazione”, ai Periodici Rizzoli, al “Giornale“, alla Rai e al Corriere della Sera.
 Il Tottenham sarebbe sulle tracce di Nicolò Fagioli, centrocampista classe 2001 della Juventus e della nazionale azzurra: stando a quanto riportato dal portale inglese specializzato "GivemeSport.com", i londinesi potrebbero tentare l'assalto al giocatore...
Il Tottenham sarebbe sulle tracce di Nicolò Fagioli, centrocampista classe 2001 della Juventus e della nazionale azzurra: stando a quanto riportato dal portale inglese specializzato "GivemeSport.com", i londinesi potrebbero tentare l'assalto al giocatore...
 La Juventus, sul proprio sito ufficiale, fa il punto sulle giocatrici delle Women che saranno in campo oggi con le rispettive nazionali: "
Ultima tornata di impegni con le nazionali per le bianconere convocate dai rispettivi commissari tecnici.
Quest'oggi,...
La Juventus, sul proprio sito ufficiale, fa il punto sulle giocatrici delle Women che saranno in campo oggi con le rispettive nazionali: "
Ultima tornata di impegni con le nazionali per le bianconere convocate dai rispettivi commissari tecnici.
Quest'oggi,...
 Archiviata la vittoria in Youthe League contro l'Aston Villa, la Juventus Under 20 torna a concentrarsi sugli impegni del campionato.
Domenica 1° dicembre alle ore 11 la squadra di Magnanelli affronterà alle ore 11 il Sassuolo in trasferta per la...
Archiviata la vittoria in Youthe League contro l'Aston Villa, la Juventus Under 20 torna a concentrarsi sugli impegni del campionato.
Domenica 1° dicembre alle ore 11 la squadra di Magnanelli affronterà alle ore 11 il Sassuolo in trasferta per la...
 13:55 - IL REPORT DELL'ALLENAMENTO - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha fornito i dettagli della seduta odierna: "È tornata al lavoro la Juventus dopo la trasferta di Lecce.Dopo tre gare esterne consecutive, i bianconeri tornano...
13:55 - IL REPORT DELL'ALLENAMENTO - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha fornito i dettagli della seduta odierna: "È tornata al lavoro la Juventus dopo la trasferta di Lecce.Dopo tre gare esterne consecutive, i bianconeri tornano...
 Se vi dicessimo che per la questione ultras è tutto fermo e non succederà nulla? Sicuramente nessuno si stupirebbe, del resto in Italia funziona così e le cose non cambieranno.
Esistono due versioni di giustizia, quella che riguarda tutte le...
Se vi dicessimo che per la questione ultras è tutto fermo e non succederà nulla? Sicuramente nessuno si stupirebbe, del resto in Italia funziona così e le cose non cambieranno.
Esistono due versioni di giustizia, quella che riguarda tutte le...