Gli eroi in bianconero: Gianluca PESSOTTO

Pessottino per chi gli vuole bene. E sono in tanti che lo stimano e che gli vogliono bene. Vent’anni di calcio, comincia a quattordici nelle giovanili del Milan; vive in collegio e la solitudine, il freddo, la nostalgia di tanti bambini che crescono così, con il loro sogno sotto il cuscino sono i suoi compagni di camera. È stato un trauma lasciare il suo Friuli, poco più che ragazzo. Lontano da casa sente la mancanza della famiglia, degli affetti più cari, degli amici di infanzia. Stringe i denti, fa grossi sacrifici e studia da perito aziendale e corrispondente in lingue estere, sognando di diventare un calciatore famoso, come i neo Campioni d’Europa del Milan che, tra gli altri, allineano Carletto Ancelotti.
A quel tempo, Pessotto, aveva già imparato cosa significa vivere in un collegio aperto a tutti, lavare la propria biancheria intima e mangiare cibi scotti. Gianluca ricorda che, quella del Milan, fu una scuola di vita importante e, se uno resiste a certe prove, nulla più lo spaventa. Pane duro, dunque, prima di pasteggiare a caviale e champagne, si fa per dire, grazie al calcio miliardario.
Dalla gestione Farina, il Milan passa a quella di Berlusconi e la situazione, anche a livello giovanile, migliora notevolmente sotto il profilo economico: «Il mio rimpianto più grande è quello di non aver continuato gli studi, come desideravo. Mi ero sposato con Reana, conosciuta a Varese quando ero in prestito nella squadra lombarda, e stavo superando i test per l’ammissione alla facoltà di Psicologia, quando è nata Federica. Mia figlia ha assorbito completamente le mie attenzioni, dopo l’incredibile full immersion calcistica che ho fatto nella Juventus. Quando è venuta al mondo, ero in ritiro per un mese e riuscivo a vederla con il contagocce. Allora ho capito che, nelle vesti di papà, dovevo dedicarmi a lei e a Reana. Per questo ho messo da parte i libri, il mio cruccio. Ed anche gli hobby. Ma la famiglia è molto più importante. Quando ero giovane mi è mancata parecchio».
Il sogno di una carriera normale che poi diventa grande: «Dai ragazzi del Milan al Varese, prima in C2 e poi in C1. Dal Varese alla Massese, ancora in C1 e, subito dopo, il passaggio di categoria, nel Bologna e nel Verona. Dalla B alla A con il Torino dove debuttai in prima squadra al Delle Alpi contro l’Inter, nel settembre 1994. Vinsero i neroazzurri 2-0, ma fu un ottimo campionato. Vincemmo entrambi i derby e avemmo la fortuna di essere l’unica squadra a battere due volte la Juventus. È stata una stagione importante, anzi inventandomi terzino sinistro, Sonetti fece la mia fortuna. Io sono destro naturale, anche se scrivo con la sinistra. E c’è carenza di mancini che giocano in difesa. Lo stesso Maldini è un destro che ha trovato la propria strada a sinistra. Naturalmente, Paolo è il più grande. Un problema, quello del fluidificante di sinistra, che aveva pure quel Torino. E Sonetti trovò la soluzione, cambiandomi la posizione che era originariamente quella di mediano destro, anche se, saltuariamente, mi ero cimentato sul versante opposto. Un segno del destino».
Con la Juventus gioca 366 volte, vince sei scudetti e tutte le coppe, compresa la Champions League, nel 1996, contro l’Ajax ai rigori. Uno lo segna proprio lui come quell’altra volta, agli Europei 2000 in semifinale contro l’Olanda. È la partita del “cucchiaio” di Totti, ma un altro pallone lo mette in porta proprio Pessottino, ancora una volta contro Van der Sar, suo futuro compagno bianconero.
Si rompe il ginocchio nell’amichevole prima dei Mondiali 2002: li avrebbe giocati da titolare, invece, sta fermo sette mesi. La sua carriera finisce con l’ennesimo scudetto, il ventinovesimo bianconero, quello più amaro.
«La Juventus è il massimo. Tante le gioie. Poche, anche se bruciano ancora, le delusioni. Nel primo campionato ci piazzammo secondi, ma poi vincemmo la Champions League. Mi viene ancora la pelle d’oca se penso a quando ho tirato uno dei calci di rigore che ci diedero il trionfo. Era una coppa cui la società teneva moltissimo dopo quella dello stadio Heysel, insanguinata e piena di polemiche. L’anno successivo, purtroppo, mi infortunai al tendine d’Achille e dovetti dare forfait a Tokyo, un appuntamento con gli argentini del River Plate che ci tenevo tantissimo a non perdere. Partecipai comunque alla gioia dei miei compagni. Purtroppo, dietro l’angolo, per me, c’era stata la iella. Lo scudetto mi ripagò, con gli interessi, di quell’amarezza e dell’altra, a Monaco di Baviera, nella finalissima persa con il Borussia Dortmund. Quella sera mi toccò soffrire in panchina. Ma non la dimenticherò facilmente».
Diventa Team Manager, prima di quel gesto difficile da spiegare, gesto che tutti vorrebbero dimenticare il più presto possibile: «Di quella mattina non ho un reale ricordo, ma tra le mani avevo un rosario. Prima provavo un forte senso di vuoto, un male nell’anima e una grande solitudine, nonostante le tante persone che ti stanno attorno. Quanto esci da una sofferenza ne trai sempre qualcosa di positivo, di costruttivo. Rivedi tutto, rivaluti tutto e ne esci più forte, con qualche cicatrice, ma sei più forte. L’affetto della gente mi ha aiutato moltissimo ed è una cosa bellissima, se dai amore ricevi amore. Se dovessi fermarmi a ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicini nei mesi difficili, non finirei più. Così come la squadra che, addirittura, su decisione di Del Piero e dei vecchi dello spogliatoio, ha ritirato la maglia numero sette».
Lo chiamano il Professore; ha l’aria dell’insegnante, quando inforca gli occhialini e si tuffa nella lettura di un libro: «Schopenauer e Dostoevskij sono i miei autori preferiti, ma è “Il piccolo principe” il libro che mi ha maggiormente affascinato; attraverso una favola per bambini, lo scrittore ha voluto trasmettere l’insegnamento di quei valori che vanno contro il materialismo imperante della nostra società. Penso di essere così anch’io; sin da piccolo ho sempre preferito l’essere dall’apparire».
L’amore esasperato per la moglie «Reana è come la Juventus, la migliore che potessi mai sposare» e per le splendide figlie Federica e Benedetta. E poi il sorriso e la sua lealtà; come quella volta a Perugia. La Juventus sta perdendo lo scudetto; ultimi minuti, l’arbitro dà una rimessa ai bianconeri, ma lui dice che è un errore e restituisce la palla all’avversario.
«Vivere, prima di tutto, E camminare, muovere i primi passi incerti, sentire di nuovo la terra sotto di te, procedere spediti verso l’indipendenza; una sensazione stupefacente, la cosa più bella in assoluto. Non parliamo, poi, della gioia che ho provato quando, per la prima volta, ho potuto guidare di nuovo la macchina. Non mi sarei più fermato, ho girato e rigirato per tutta Torino, libero e con la mente sgombra, senza più quegli incubi che mi avevano accompagnato nel mio girovagare, sconvolto, per le stesse strade, in quel lontano sabato di fine giugno. Mi sentivo come un bambino sulla giostra, così felice che non avrei mai voluto interrompere il divertimento ritrovato».
Questo è Gianluca Pessotto.
ANDREA NOCINI, DA PIANETA-CALCIO.IT DEL 12 OTTOBRE 2013
È uno dei pochi calciatori laureati; l’alloro gli fa conquistare l’appellativo di "professorino". Rimasto alla Juventus come dirigente (team manager), la mattina del 26 giugno 2006, in piena crisi, si lancia impugnando un rosario da un abbaino della sede bianco-nera a Torino, ma si salva miracolosamente, anche perché termina il volo sulla capotta dell’automobile di Roberto Bettega, allora vice-presidente della Juve. Vince il suo calvario di crisi spirituale e di dolore fisico, e continua la sua carriera di dirigente bianconero.
– Quando è, direttore, che le è venuta per la prima volta la pelle d’oca? «Quando ho giocato una partita vera, in uno stadio pieno; lì sentii veramente un’emozione unica. Quindi, ogni esordio, ma, soprattutto, quella partita che ti immagini da bambino, no, quando affronti grandi squadre, quando debutti in Champions League, quando debutti in campionato. Ma, più di tutti, l’esordio in Serie A è stato da pelle d’oca: con la maglia del Torino, al vecchio Comunale, contro l’Inter, anche se perdemmo 0-2».
– Cosa è che le manca nel suo ricco carnet? «A livello di trofei, qualche Champions League in più, poiché abbiamo conquistato quattro finali e ne abbiamo perse tre. Nella mia vita desideravo disputare un Mondiale con la Nazionale, desideravo vincere una Champions League, ma non ho rimpianti».
– Il goal più bello e quello più pesante? «Il goal più bello è quando Gianluca Pessotto si è sentito felice di quello che ha fatto, perché convinto di aver dato il meglio di sé. Il goal più bello è essere soddisfatti di se stessi. Poi, il riconoscimento da parte degli addetti ai lavori di essere stato un esempio positivo a livello di sportività. Per l’uomo Gianluca è una grande vittoria».
– “Schemi e Patemi”, questo il titolo del libro: quali sono le certezze e quali invece le sue paure quotidiane? «I patemi sono quelli di domandarmi se ogni giorno, lavorando con i giovani del vivaio della Juventus, riesco a trasmettere messaggi utili a livello di comportamento e di passione che ho dentro di me. Il mondo pazzo del calcio è bellissimo. Voglio mettermi alla prova nel cercare di riuscire ad aiutarli a raggiungere i loro sogni. E di realizzare gli obiettivi che la mia società si è posta: quello, in testa, di far crescere tutto il movimento giovanile: questa è la mia mission e anche il mio patema. Il mio schema, quello che ha contraddistinto la carriera di Pessotto calciatore, è stato il lavoro e l’attenzione a ogni particolare. Sopravvivo ai patemi attraverso il lavoro, lavoro, lavoro, continuando a rimboccarmi le maniche».
– Cosa è che le dà fastidio e cosa la riesce ancora a colpirla, a stupirla, a commuoverla? «Mi fa arrabbiare l’idea generale dell’opinione pubblica di un non futuro, la sensazione di un paese che non vuole crescere, che è convinto di non farcela a uscire dalla crisi, dalle difficoltà a ogni livello; anche nel mondo del calcio. Mi emoziona la semplicità e la fiducia della gente comune, quando si incontra per strada. Nel vedere come ci si emozioni per le piccole cose: io mi emoziono ogni volta che vedo un campo da calcio pieno di bambini che giocano e dentro di me dico che, nonostante tutte le difficoltà che si sentono in giro, economia, guerre e altro, però, alla fine un campo da calcio pieno di bambini vocianti e che rincorrono, spensierati e divertiti, la palla mi riempie di gioia e dà l’idea di una grande sollievo e di una palpabile distensione».
– Di che cosa non può fare a meno nella vita di tutti i giorni? «Del calcio, di sicuro, sotto tutti i suoi aspetti. Mi piace vederlo, mi piace trattarlo, mi piace condividerne le amarezze e le gioie che ti trasmette, ed è veramente la mia vita».
– Gianluca Pessotto juventino da sempre? «No, da piccolo ero milanista, ma, devo dire che poi ho trovato, nella Juventus, la società nella quale completarmi e realizzarmi. Anche caratterialmente, oltre che dal punto di vista calcistico. Ho avuto la fortuna di crescere in una società vincente come il Milan, che ti aiuta a creare la mentalità vincente, e poi sono riuscito a completare il mio percorso in una società come la Juventus, con più di cento anni di storia e vincente. Ed è il massimo dei miei sogni, delle mie ambizioni».
– Un Pessotto più forte, più limpido e più equilibrato da quel tragico mattino del 26 giugno 2006? «La sofferenza vissuta in quei mesi, prima e dopo, in quegli anni in cui il percorso della mia rinascita è durato del tempo, al di là delle cicatrici nel corpo rimaste e qualcuna nel cuore, sicuramente mi ha aiutato molto a ridefinire alcune cose. La sofferenza ti aiuta a crescere, io ho conosciuto un punto davvero basso della mia anima, di me stesso e della mia vita, dove ho avuto paura di morire, e oggi non ho smesso di avere paura ma la vivo meglio. E, quindi, sicuramente, da questo punto di vista, mi sento molto più sicuro, molto più forte e molto più semplice. Il grande insegnamento di tutto quello che ho vissuto è che la mia voglia di sentirmi perfetto è stato l’errore più grande che io potessi commettere, è stata la mia debolezza e la mia forza e viceversa».
– Quindi, il suo più grande, sommesso pianto è stato quando ha potuto, riaprendo gli occhi, rivedere la moglie e le sue due figlie? «Esattamente: il primo sorriso che ho riconosciuto è stato quello delle mie figlie, la prima parola che ho potuto pronunciare è stato il nome delle mie figlie, la prima parola che ho potuto dire di nuovo è stato il mio nome ed è come se fossi tornato bambino, quando ti insegnano a pronunciare il tuo nome. Ecco, il paragone mi sembra che calzi per quello che ho vissuto in quei momenti».
– Cosa è che l’ha aiutata a venirne fuori? «In quei giorni lì, di dolore, io mi sono portato nel cuore una poesia, un salmo che mi ha donato un’infermiera delle Molinelle, e che porto ancora oggi con me, nella testa, nel cuore, e che diceva: “Camminavo sulla spiaggia, a fianco di Dio, e a un certo punto mi guardo dietro e vedo solo due orme. Alzo gli occhi al cielo e chiedo ma perché Gesù mi hai abbandonato?” Lui mi guarda e mi dice: “Sciocco, non vedi che non ti ho abbandonato, ti sto solo tenendo in braccio!” Ed è una cosa che mi ha segnato e che mi guida tutt’ora in ogni mio percorso».
– È una frase tratta da un anonimo brasiliano. «Sì, è vero! Non sono uno abituato a esternare le mie emozioni, ma oggi dover riuscire a descrivere quello che ho vissuto, anche quelle di paura, è la più grande battaglia ed è anche la mia grande mission con i giovani. Sono convinto che non bisogna avere paura di emozionarsi, le emozioni non sono debolezze».
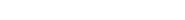





 Nessuna telefonata di Moggi con gli arbitri. Nessuna partita alterata. Chi indossa il nostro scudetto e lo mette in mostra con una copia, ha raggiunto il punto più basso di etica sportiva.
Nessuna telefonata di Moggi con gli arbitri. Nessuna partita alterata. Chi indossa il nostro scudetto e lo mette in mostra con una copia, ha raggiunto il punto più basso di etica sportiva.
 Secondo indiscrezioni raccolte da Tuttojuve.com, uno dei nomi accostati nuovamente ai bianconeri è quello di Danylo Sikan (23) dello Shakhtar Donetsk. L'attaccante, però, non stuzzica le idee della dirigenza bianconera, che sul fronte attaccanti potrebbe...
Secondo indiscrezioni raccolte da Tuttojuve.com, uno dei nomi accostati nuovamente ai bianconeri è quello di Danylo Sikan (23) dello Shakhtar Donetsk. L'attaccante, però, non stuzzica le idee della dirigenza bianconera, che sul fronte attaccanti potrebbe...
 Juve impegnata domenica sera a Monza. Dopo il successo in Coppa Italia, serve una svolta anche in campionato, per...
Juve impegnata domenica sera a Monza. Dopo il successo in Coppa Italia, serve una svolta anche in campionato, per...



 Andrea Bosco ha lavorato al “Guerin Sportivo“, alla “Gazzetta dello Sport“, al “Corriere d'Informazione”, ai Periodici Rizzoli, al “Giornale“, alla Rai e al Corriere della Sera.
Andrea Bosco ha lavorato al “Guerin Sportivo“, alla “Gazzetta dello Sport“, al “Corriere d'Informazione”, ai Periodici Rizzoli, al “Giornale“, alla Rai e al Corriere della Sera.
 Il Napoli avrebbe praticamente chiuso con il Lecce la trattativa per la cessione a titolo definitivo del cartellino di Luis Hasa, trequartista classe 2004 cresciuto nelle giovanili della Juventus. Come riportato da "Calciomercato.com", l'accordo tra le parti...
Il Napoli avrebbe praticamente chiuso con il Lecce la trattativa per la cessione a titolo definitivo del cartellino di Luis Hasa, trequartista classe 2004 cresciuto nelle giovanili della Juventus. Come riportato da "Calciomercato.com", l'accordo tra le parti...
 Il colosso dello streaming Netflix ha deciso di entrare in maniera importante nel mondo del calcio. Come annunciato in un comunicato infatti è stato raggiunto uno storico accordo con la FIFA per i diritti in esclusiva per gli Stati Uniti d’America per le...
Il colosso dello streaming Netflix ha deciso di entrare in maniera importante nel mondo del calcio. Come annunciato in un comunicato infatti è stato raggiunto uno storico accordo con la FIFA per i diritti in esclusiva per gli Stati Uniti d’America per le...
 La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, informa i tifosi bianconeri su dove vedere il match del campionato Primavera che i bianconeri giocheranno domani, a partire dalle 13:00, contro l'Atalanta a Zingonia:
U20 | ATALANTA-JUVENTUS, DOVE VEDERLA
"La...
La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, informa i tifosi bianconeri su dove vedere il match del campionato Primavera che i bianconeri giocheranno domani, a partire dalle 13:00, contro l'Atalanta a Zingonia:
U20 | ATALANTA-JUVENTUS, DOVE VEDERLA
"La...
 15:22 - ALLENAMENTO IN CORSO - La Juventus è in campo e si sta allenando in vista del match contro il Monza.
14:50 - A BREVE JUVE IN CAMPO - A breve la Juventus sarà in campo per allenarsi in vista della gara contro il Monza. In questa...
15:22 - ALLENAMENTO IN CORSO - La Juventus è in campo e si sta allenando in vista del match contro il Monza.
14:50 - A BREVE JUVE IN CAMPO - A breve la Juventus sarà in campo per allenarsi in vista della gara contro il Monza. In questa...
 La partita con il City è cambiata con due episodi, il primo Di Gregorio che salva su Haaland nel primo tempo e nel secondo la cavalcata di Federico Gatti che rompe gli schemi e fa ripartire la Juve innescando poi l'azione che porta al gol.
ROMPERE GLI...
La partita con il City è cambiata con due episodi, il primo Di Gregorio che salva su Haaland nel primo tempo e nel secondo la cavalcata di Federico Gatti che rompe gli schemi e fa ripartire la Juve innescando poi l'azione che porta al gol.
ROMPERE GLI...